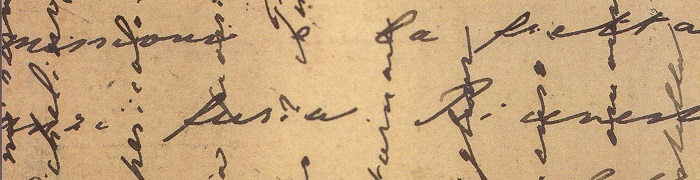
- Dettagli
- Scritto da Giovanni Gentile
- Categoria: Conferenze
- Visite: 3203
Conferenza tenuta il 25 giugno 1910, pubblicata su «La critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce» VIII, (1910) pp. 263 ss. e 339 ss. (La filosofia in Italia dopo il 1850, III - I positivisti, X - Intermezzo: Simone Corleo)
I
Prima di venire alla conchiusione di questo qualsiasi disegno storico del positivismo italiano nella seconda metà del secolo XIX, e di studiarne gli ultimi rappresentanti, in cui esso s’è quasi corrotto, ed è morto, apro una parentesi per ricordare l'unico filosofo che in questo periodo ebbe la cultura siciliana; un filosofo rimasto sempre, quasi albero piantato nel campo in cui ha le radici, chiuso col suo pensiero nello stesso àmbito della cultura isolana, non ancora fusa nella vita nazionale dello spirito italiano. Tutta la vita Simone Corleo (n. a Salemi il 2 settembre 1823, morto il I° marzo 1891 professore di Filosofia morale nell'Università di Palermo) desiderò ed attese un adeguato riconoscimento dell'originalità, del valore dei suo pensiero: ripetendo sempre (e non aveva torto) che nessuno aveva letto tutta un'opera sua, o almeno nessuno inteso, nel loro complesso, le sue dottrine. E ricostruendo nel 1879 in una forma più agevole e piana il sistema della sua filosofia, da vent'anni già esposto in due grossi e fitti volumi di più che mille e dugento pagine complessive, annunziava intanto il proposito «di richiamarvi meglio l'attenzione de più valorosi intelletti con preparare a suo tempo, sull'asse suo, alcuno di quei mezzi che sogliono incoraggiare agli studii più difficili e meno retribuiti»1. Proposito, che infatti mantenne nel suo testamento, istituendo un assai cospicuo premio per gli studi intorno alla sua filosofia, a fine di promuovere artificialmente quell’interesse, che non era mai sorto naturalmente2. Non era sorto, perché non poteva sorgere; non per quella generale cagione, onde il Corleo procurava da se stesso di consolarsi: che cioè «nelle scienze filosofiche, ciò che comunemente o almen da molti si loda, corrisponde al volgare modo di pensare, o per lo meno al pensare dei proseliti di una scuola venuta in moda»: cagione che è vera, solo per metà, giacché essa moda si crea appunto, non da ciò che comunemente è lodato, ma dal vigore possente d’ogni nuova concezione originale; non poteva sorgere, perché la filosofia del Corleo s’era formata in un ambiente di pensiero estraneo alle grandi correnti contemporanee; in quell’ambiente chiuso, quale rimase sempre la cultura siciliana fino al 1848 (quando qui si sorse per la prima volta l’idea della unità italiana): chiuso anche al soffio turbinoso e ricreatore della grande Rivoluzione; chiuso quindi e in ritardo verso il rinnovamento spirituale della penisola nella prima metà dell’800. Ambiente, che sarà studiato in altra serie d’articoli, ma che si può facilmente riconoscerne e quasi sentire in quel che d’esotico, che a chi non abbia familiarità con gli studi filosofici siciliani d’innanzi al 1860 desta un così vivo senso di strano, e stavo per dire di repellente, nelle opere, nelle opere di Simone Corleo, specialmente nelle prime. Esotica la lingua, con tutta la forma letteraria, diversa da quella degli scrittori italiani del continente contemporanei, non pure nei costrutti non sempre conformi alle norme più generalmente seguite, ma nella stessa materia della lingua e nella frase, tra barbara e preziosa, e nell’atteggiamento stilistico d’un classicismo di scuola, in cui l’abbondanza ciceroniana e cinquecentesca s’alterna e si mescola alla magrezza stringata di Tacito e dell’Alfieri3. Esotico tutto l’atteggiamento storico; per cui la storia si trasfigura in funzione della cultura speciale palermitana, secondo interessi intellettuali e tradizioni paesane. Esotica la posizione dei problemi, derivanti da una storia siciliana della filosofia; e la stessa situazione mentale rispetto alla realtà, verso la quale il pensiero contemporaneo è orientato: situazione, ancora all’albeggiare del '6o, da abati del sec. XVIII, per cui la filosofia era la fisica e la matematica - i dommi cristiani; e la storia, l'uomo, non era. Se la Sicilia fosse rimasta la Sicilia, Simone Corleo, quando nel 1860 e 63 diè in luce la sua Filosofia universale, che doveva cacciar di nido il Sistema di scienza universale, pubblicato nel 1850 dal monrealese p. Benedetto d'Acquisto (1790-1867; predecessore del Corleo nella cattedra dell'università palermitana), che alle tradizioni d'una scuola locale aveva congiunto alcune novità giobertìane4, egli avrebbe certo raccolto tutto il plauso de' suoi connazionali; com'ebbe sempre a Palermo una cerchia di scolari devoti e di entusiasti ammiratori, che non lasciano tuttavia spegnere l'eco della sua voce. Ma già allora la Sicilia cominciava a diventare l'Italia; l'Italia tutta impregnata dello spirito nuovo del romanticismo, integratore e correttore dello spirito della Rivoluzione; l'Italia, che, ripigliando il suo posto tra le nazioni d'Europa, si affrettava per rimettersi anche al passo con i progressi universali della cultura. E in questa Italia, che fin d'allora assunse nel circolo della sua vita nuova la Sicilia, il Corleo, che nel 1860 si presentava con un'opera già da diciotto anni meditata e promessa5, parlò come vox clamans in deserto. Nessuno l'ascoltò, nessuno6 gli rispose. Fu, come si dice, uno spostato.
E se ora levasse il capo e vedesse questo saggio, non dubiterebbe, certo, un solo istante dell'opportunità di essere studiato quasi a parte e in un intermezzo alla storia della filosofia contemporanea: ma non meno certamente si riterrebbe spostato in un intermezzo alla rassegna dei positivisti. Poiché positivista egli non credette mai di essere, quando venne in auge In Italia il positivismo, e gli parve di dover farei conti con esso7. Il positivismo - quello almeno dei positivisti, poiché un positivismo a modo proprio non c'è chi non lo voglia - egli lo combatté in tutte le sue affermazioni più caratteristiche. E nessuno, che io sappia, ha creduto finora di poterlo raccostare a' positivisti. Egli, contro i positivisti, professò di essere metafisico; e affermò l'eterogeneità e l'autonomia dello spirito; e la finitezza del mondo; e Dio; e la creazione: tutta la sostanza della metafisica cristiana, che i positivisti rimandavano ai musei preistorici; e contro i positivisti difese sempre i diritti della filosofia come scienza diversa dalle scienze particolari, e legislatrice per tutte.
Ma la filosofia d'un filosofo, si sa, non è quella stessa per l'appunto, che vuol costruire esso il filosofo: ma soltanto quella che il pensiero fondamentale, l’ispirazione prima del suo filosofare gli lascia e quasi gli fa costruire. Non basta che il filosofo sia di fatto, cioè voglia essere, meccanista e finalista, materialista e spiritualista, perché gli si riconosca in linea di diritto che egli è una cosa e l’altra, poiché l'una cosa esclude l'altra; e lo storico della filosofia deve distinguere trai due principii repugnantì quello che è veramente originario, e solo può dirsi perciò il vero principio del filosofo. Che se, oltre il principio da cui egli prende le mosse, sente pure il bisogno e la forza d'un principio opposto, questa duplicità d'interesse, questo antagonismo interiore è allo storico dimostrazione prammatica dell'insufficienza logica e storica del principio fondamentale. Che è il caso del Corleo; positivista in tempo di positivisti ma con tutto un bagaglio addosso di vecchia metafisica, che gli impediva d'entrare nel gran carrozzone, su cui quei signori si caricavano e viaggiavano beati: ma il suo bagaglio, se accenna a certa ingenuità da spostato, se non gli procurò fortuna tra i positivisti, se non gliela fece né anche cercare in quel campo, se gli dié una particolare fisonomia storica, non significa a chi guardi alla logica interna del suo pensiero se non il difetto e quasi il fallimento del suo stesso positivismo. Onde l'intermezzo siculo assume l'importanza d'una critica ab intrinseco del positivismo italiano, dovuta a un filosofo che per altre vie, per altri porti giungeva a cotesta filosofia largamente diffusa nel tempo suo.
- al. vol. Il sistema della filos. Universale, ovvero la filos. della identità, Roma, 1879, p. 6.
- Malgrado l’insistenza, onde egli tentò sempre attirare suoi libri l’attenzione dei più illustri scrittori del tempo, e provocarli a pubblica discussione. Vedi le lettere raccolte nell’Appendice a questo saggio.
- Chi voglia rendersi conto dell’educazione letteraria del Corleo, deve leggere il suo volume Tragedie seguite da discorsi politici e letterarii, 2aed, Palermo, 1869: contenente quattro tragedie (Vespro siciliano, Eufemio, Silano, Tiberio Gracco) e due discorsi: Sui Gracchi, sul Comunismo e sul limite massimo della proprietà; e Sulla tragedia italiana.
- Sul D’Acquisto, dal 1844 al ’58 professore nella Università di Palermo, poi arcivescovo di Monreale, v. Di Giovanni, B. D’A. e la filos. della creaz. in Sicilia, Firenze, 1867, e St. d. filos. in Sicilia, Palermo, 1873, II, 213-289.
- univ., vol. I. Intr.
- Nessuno, s’intende, che mostrasse di consentire. Della Filosofia universale si occuparono Luigi Ferri, Ital. Ed Effem. Della P.I., Torino, 2 dicembre 1861, n. 63; A. Conti, ivi, 15 settembre 1862, n. 104; B. Poli, ivi, 7 aprile 1862, n. 81; G.Allievo, ivi, 13 febbraio 1865, n. 229 (scritto rist. nei Saggi filosofici, Milano, 1866, pp. 324-334); F. Bonatelli, Riv. cit., 24 aprile, n. 187, e nell’art. Die Philos. in Italien seit 1815 nella Zeitscr. f. Philos. u. philos. Krit. N. F., Bd LIV N. F., (1869), pp. 134-58; A. Franchi, Teorica Del giudizio, 1870, lett. XI; F. Fiorentino, La filos. contemp., p.60. Nella rivista La filosofia, rassegna siciliana che il Corleo fondò nel 1890, ma di cui non riuscì a pubblicare più di due fascicoli, nell’anno II (dopo il quale cessò) dir. da R. Benzoni, contiene vari scritti commemorativi intorno al Corleo nei cenni necrologici e biografici. Il Benzoni vi studia il Car. Della filos. di S. C.; il medico A. Marcacci, Le opere medico-fisiche di S.C. ed il suo sist. di filos. univ.; E. Orestano, L’identità in Bain e in Corleo. Un cenno bio-bibliografico del C. scrisse F. Orestano nella miscellanea di scritti in onore di M. Heinze, Berlin, Mittler u. Sohn, 1906, pp.201-206.
- Vedi specialmente il suo scritto Le differenze tra la filos. dell’identità e l’odierno positivismo, nella Riv. Di filos. scient. Del febbraio 1887.
II
E in primo luogo è da notare che Simone Corleo, di fatto, prese le mosse dallo studio di problemi particolari di fisica e di fisiologia. Le sue Ricerche su la vera natura déi creduti fluidi imponderabili erano bensì pubblicate dall'autore ventinovenne come «lavoro destinato a spianar la strada ad altro lavoro assai più esteso e più rilevante, la Filosofia universale... tempo avanti promessa, ma per fatali ostacoli non condotta ancora a compimento»1; ma, anzi che presupporre realmente questa filosofia universale, sono evidentemente la stessa prima forma di essa filosofia, quale sorse nella mente del Corleo nel tentativo di approfondire i concetti empirici di calore, luce ed elettro-magnetismo, combattendo la mitologìa è vecchi fluidi imponderabili: onde si rompeva con una serie di casi eccezionali la legge newtonìana della gravitazione universale, ammettendo corpi assolutamente o relativamente non gravi. Il Corleo si sforza di chiarire come tutti i fenomeni, che si ritenevano effetto di questi presunti fluidi, non importino realmente nulla di estraneo alla meccanica dei corpi ponderabili cui ineriscono, e si risolvono tutti in stati di questi corpi: onde il calorico non sarebbe più un agente che dilata i corpi, ma la stessa dilatazione dei corpi, immanente in tutti i corpi, proveniente dalla continua variazione dello stato di aggregazione delle loro molecole, a causa dello squilibrio e del moto incessante dei varii corpi, contigui tutti, dell'universo. La luce, anch'essa, uno stato degli stessi corpi ponderabili; ossia il particolare stato vibratorio delle stesse molecole di cotestì corpi. E uno stato particolare delle molecole dei corpi ponderabili anche l'elettricìtá, derivante dal loro disequilibrio molecolare. Non occorre qui entrare nella serie delle, osservazioni onde egli confuta la pretesa azione degl'imponderabili, e spiega i fenomeni termici, luminosi ed elettrici con la meccanica dei ponderabili. Giova piuttosto accennare in breve i fondamenti di questa meccanica, che sono l’intuizione generale, che il Corleo ha di tutti i menzionati fenomeni fisici.
La materia, egli dice, consta di elementi indivisibili, perché altrimenti non vi sarebbero corpi più grandi e corpi meno grandi, tutti essendo divisibili all’infinito, ossia tutti egualmente divisibili, in quanto un infinito a sua volta non potrebbe essere maggiore o minore di un altro. Questi elementi non sono atomi inerti, veicolo di movimento, ma atti (monodinamie): «forze esse stesse attuate» che, «riunendosi, produrrebbero un'azione totale, equivalente alla somma totale dei loro numeri e della loro disposizione». Monadi, insomma, come quelle di Leibniz, centri di attività: ma forze attuate, che, a differenza delle monadi leibniziane, son tutte attuate: ossia ciascuna è attuata si da non essere, né per forza propria, ne per forza altrui, suscettibile di altra ulteriore attuazione: scevra d'ogni possibilità di svolgimento: «ognora la stessa determinata invariabile azione». La monade leíbnìzíana è un continuo cangiamento, é l'azione d'un principio interno che passa per appetizione da una percezione all'altra. La monodinamia del Corleo è identità assoluta con sé stessa, negazione d'ogni cangiamento. Che sia l'atto senza cangiamento della monodinamia ora non indaghiamo. Anche il pensiero, che muove essendo immobile, è per Aristotìle un atto. Ma il carattere differenziale che distingue più profondamente la monodinamia dalla monade leibniziana, e da quel reale herbartiano, a cui il principio del filosofo siciliano è stato più volte raccostato, e che giova a significarne più precisamente il valore, è la sua relatività, laddove ogni cangiamento della monade è per Leìbniz interno alla monade stessa, che non ha finestre, per cui qualcosa possa entrarvi o uscirne, e ogni attività del reale si esaurisce per Herbart nell'autoconservazione del reale, che è anch'esso un tutto chiuso ed essenzialmente irrelativo. «L' idea di azione», dice invece il Corleo (e azione è per lui, la stessa entità elementare), «accenna da se stessa la necessità di una relazione ad altri, la necessità di un contatto»; essa «non può avere per limite il pretto nulla» e va quindi concepita «come dentro una sfera di contatti di altre azioni sostanziali, che l'abbracciano e la serrano da ogni dove». L’azione della monade pel Corleo non è a sé, ma ad altro: e la monade non è, come avrebbe detto Herbart, una posizione assoluta, non e sé stessa, ma è sé stessa ed altro, e il suo essere trascende la sua sfera particolare per adeguarsi a tutta la sfera di contatti, al sistema ìnsomma di cui fa parte. Non occorre avvertire che questa monade non è l'atomo, il quale presuppone lo spazio vuoto, che il Corleo rifiuta; ma non occorre neppure avvertire che una monade la quale non è per sé, ma è parte di un sistema, non è più monade, non è più nulla di sostanziale. Ma, benché il Corleo ci parli anche in questa introduzione alle Ricerche sugl’imponderabili di concetti metafisici, è giusto interpetrare le idee che vi propone alla stregua della speculazione pura? A lui importa qui di costruire un sistema fisico, in cui la stessa aggregazione delle parti materiali, secondo una ipotesi unica, renda ragione di tutti i fenomeni fisici, senza bisogno di postular nulla che trascenda lo stesso sistema fisico. Questo bisogno soggettivo di non uscire dal campo empirico si manifesta fin dal principio nella ragione addotta per la negazione della divisibilità infinita della materia (e quindi per la posizione del numero finito degl'indivisibili). Le contrarie supposizioni dei geometri, egli dice, sono ineffettuabili in quanto urtano nella impossibilità di spiegare la differente grandezza dei corpi: che sono differenti perché - è chiaro - sono empiricamente differenti. E l'esperienza qui che costruisce i suoi presupposti, come accade sempre nella costruzione propriamente scientifica; non è un principio a priori che costruisca deduttivamente l'esperienza. Inoltre: la posizione del numero finito degli elementi costitutivi del corpo empirico non si giustifica se non in quanto gli elementi siano della stessa natura del tutto, unità, cioè, della stessa specie di quelle che compongono il tutto. Ma questa identità non è concepibile se non a patto che le unità siano nello stesso piano del tutto, e se questo è oggetto di esperienza, quelle devono essere almeno oggetto dell’esperienza, che Kant dice possibile. Se il corpo è esteso, le unità saranno estese, materiali. Dal punto di vista metafisico, Leibniz aveva chiarito che unità estese, materiali non sono unità, ma molteplicità, aggregati esse stesse di altre unità. Ma le entità supposte, così come le suppone, servivano al Corleo per condurre una polemica analoga a quella già fatta dal Leibniz nell’Hypothesis physica nova dal punto di vista del meccanismo, contro il concetto fisico dei fluidi imponderabili, dell’azione a distanza e di ogni eccezione al sistema del più matematico atomismo. E, obbedendo allo stesso bisogno spirituale, egli scrisse quattro anni più tardi un altro libro di sistemazione empirico-naturalistica: Ricerche su la natura della innervazione con applicazioni fisiologiche, patologiche e terapeutiche2; dove egli (che era medico) combatte l'altra entità scolastica del fluido nervoso, per ridurre l'attività nervosa, anch'essa, a uno stato dell'organismo, e propriamente a lo stato di mutuo disequilibrio delle molecole, che compongono l'organismo animale, raccolto in ispecialità sulla massa encefalica e sui nervi. È anche qui il desiderio di spiegare col puro meccanismo della materia le funzioni fisiologiche del sistema nervoso, che impone, com'è naturale, all'autore il concetto di una realtà materiale composta di un numero determinato di parti indivisibili, ciascuna delle quali non può essere se non se stessa, e la cui varia aggregazione deve render ragione dei fenomeni dell'esperienza. Che è il concetto del più rigoroso meccanismo, il quale risolve tutte le qualità né rapporti meramente quantitativi.
Fin da quando il suo pensiero si travagliava sui problemi particolari, e si sforzava di risolverli con la guida di cotesto concetto meccanistico del reale, egli intanto doveva, dalla posizione assunta di una concezione unitaria del mondo empirico, essere indotto naturalmente ad attribuire un valore metafisico allo schema in cui si veniva adagiando il suo pensiero. E già annunziava la Filosofia universale, pubblicata pochi anni dopo, come la dottrina immanente a quelle sue speciali ricerche. Questo scambio dello schema utile alla costruzione scientifica della natura con una logica dell'essere, ossia con una metafisica, o filosofia che si voglia dire, è non solo frequente nei naturalisti, ma necessario. Perché dal punto di vista naturalistico tutta la realtà é la natura stessa naturalisticamente considerata; e la scienza della realtà, di ogni realtà, quale è per lo spirito, non può essere che una, e assoluta per lo spirito per cui la realtà stessa è. La concezione meccanica, fisica e fisiologica, del Corleo nei Fluidi imponderabili e nel l’Innervazione fu per lui la sola, la vera metafisica del reale; e si accinse a presentarla come tale, di contro a tutte le filosofie antiche e moderne, nella sua Filosofia universale; dove in realtà egli procura di stringere nel suo pensiero non soltanto la realtà del fisico e del fisiologo, ma tutta la realtà, compresa quella additatagli da tante altre filosofie, e dal contenuto della sua fede cristiana.
- Ricerche, Palermo, Lo Bianco, 1852; Introd., p. 3. Prima di queste Ricerche nel 1844 il C. pubblicò certe Meditazioni filosofiche, che non mi è riuscito di trovare in nessuna biblioteca, e che non sono mai ricordate, che io abbia visto, dall’autore nelle sue opere posteriori: dove non manca mai di citare i lavori precedenti, in cui avesse enunciate già le stesse idee. Il Di Giovanni nella Bibliografia aggiunta alla sua Storia (II, 580) le cita come vol. I di una collezione di Opere del Corleo, rimasto incompleto, recante il sottotitolo «Filosofia»; e avverte: «Sono pensieri diversi, cui egli da titolo di Meditazioni sopra filosofici argomenti».
- Palermo, Lo Bianco, 1857, pp. 571-XXI.
III
Vediamo dunque ì tratti caratteristici di questa filosofia del Corleo, esposta da lui diffusamente nei due volumi già ricordati del 1860-63, nel riassunto fattone nel 1879 col titolo Il sistema della filosofia universale ovvero la filosofia della identità, svolta parzialmente in un corso di Lezioni di filosofia morale1, e schiarita in molti scritti minori2.
Egli muove da un'analisi del pensiero come del primo fatto, o, comunque, uno dei fatti, che la scienza si trova innanzi quando imprende le sue indagini, indipendentemente da ogni valutazione gnoseologica: ed è la prima parte del suo sistema, detta noologia; la quale non presume spiegare, ma intende osservare i carattere distintivi dei fatti del pensiero, così come essi si presentano.
E il primo fatto osservato, o creduto di osservare dal Corleo nei fenomeni del pensiero, è la complessità o composizione dì tutti i suoi atti primordiali o percezioni, esterne, interne, dell'Io, e intuitive o relative ad oggetti di conoscenza immediata. Ogni percezione, che è poi un atto effettivo di pensiero, par chiaro al Corleo che «costa di più parti, sia che le parti si distinguano fra di loro, sia che possano soltanto distinguersi per mezzo di un’analisi o di un avvertimento speciale»3; è un composto o un complesso di varie parti: e il complesso, si badi, «è identico con la somma delle parti, che in lui tratto tratto, e non tutte ad una volta si rivelano»4. Questo il primo fatto, rispetto ai quale il Corleo torna sempre a protestare che egli non fa altro che osservare, senza metterci nulla di suo; e non occorre dire che questo, come qualunque altro fatto osservato, è un fatto veduto con la lente soggettiva del pensiero che l’afferma: ossia, in questo caso, dal punto di vista meccanistico, atomistico, associazionistico, per cui si vede il molteplice del fatto psichico, ma non si vede l'uno, in cui il molteplice si concentra e si attua. E, fatto per fatto, si può affermare che, osservando esattamente, ogni percezione non è somma, ma unità.
Posta, a ogni modo, quest'atomistica spirituale, si può facilmente argomentare che tutto il processo dei fenomeni dello spirito sarà per Corleo quello che sarà peri positivisti come l’Ardigò, e che è stato sempre per tutti gli empiristi antichi e moderni; una mera meccanica psicologica, una formazione naturale, un mero incremento a posteriori dell'esperienza. Il Corleo ci parlerà di un'analisi e di una sintesi spontanea delle percezioni primitive, vera attività miracolosa costruttiva di tutte le forme del pensiero. Le percezioni, egli dice, «s'incontrano fra loro in quelle parti, ove hanno rispettiva somiglianza; e senza che l'uomo vi ponga mente, da se stessi i punti simili si rappresentano consimilmente: onde nasce la loro spontanea assimilazione», ossia una percezione sintetica che basterà a riprodurre essa sola le varie percezioni simili inerenti nei primitivi complessi di percezioni. Viceversa, tutti i punti diversi «si separano naturalmente fra loro e formano tante percezioni, o parti di percezioni, distinte». Sicché la sintesi e l’analisi, che pure il Corteo, quasi per ischerno, dice le «due grandi operazioni del Me» non sono per lui funzioni dell'Io, che rendano possibile; il duplice fatto dell'assimilazione e disassimilazione; «anzi non son'altro che il risultato delle percezioni complesse e della loro riproduttibilità»: parendogli troppo semplice e troppo naturale che «le percezioni, risovvenendosi, anche all'insaputa dell'uomo si sovrappongano, per così dire, le une alle altre, combaciandosi in tutti i punti consimili, e lasciando diversi tutti i punti non somiglianti» (I, 147), E altrove dice tranquillamente: «Tutte queste operazioni d'identificazione delle identiche rappresentazioni, di diversificazione delle diverse, di nuova identificazione dei diversi coi loro novelli identici e d'identificazione dei complessi con la somma delle parti diverse che rispettivamente li costituiscono, ovvero che in essi si manifestano, son tutte operazioni spontanee e primitive… sono il frutto spontaneo delle medesime rappresentazioni identiche e diverse, perché è impossibile che identicamente non si presenti ciò che identicamente si presenta ecc. ecc.» (Sist., § 9). Dov'è evidente l'arte dell'empirista di presupporre quel che deve dedurre: perché qui l’identificazione dovrebbe essere conseguenza dell’identità; e l’identità intanto implica l’identificazione degl'identici, che non sarebbero tali per la coscienza, se già non identificati. Ma lasciamo pure procedere il nostro filosofo; e mandiamogli buona tutta l'associazione, che egli fa derivare dall'analisi e dalla sintesi spontanea, con le operazioni psicologiche della riproduzione delle idee, la ricordanza, la reminiscenza, la dimenticanza e l'oblio. Un, altro passo innanzi, sempre con quella gamba, egli lo fa con la sua teoria dell'astrazione, che dipende sempre dall'analisi e dalla sintesi spontanea, ma scopre un nuovo mondo nel pensiero: il mondo dei concetti. «L'identico, rappresentatosi in gruppi diversi, diviene punto tipico di rappresentazione; o meglio, tutto quello che si presenta come a lui5, si presenta appunto come a lui. E perciò esso è il punto tipico per tutto ciò che lo somiglia, come è il punto differenziale per tutto ciò che non lo somiglia. Dalle frequenti ripetizioni del punto identico in mezzo a gruppi diversi, sorge la isolazione, o l'astrazione dell'identico da tutti quegli altri elementi, coi quali egli si trova unito e che non gli somigliano» (Sist., § 16). Questo astratto, manco a dirlo, è il concetto, il quale, secondo il Corleo, «in forza di questa stessa identità divenuta tipica e fissa, prende caratteri di necessità, di universalità e di assolutezza. Perocché è necessario che a presentarsi identicamente, ad entrare sotto la categoria del concetto, si presentino gl’identici connotati; in tutti i tempi ed in tutti i luoghi sarà così: ne ci vuol altro che l'identica presentazione, né meno né più, per ottenere questo effetto. Onde i così mirabili caratteri di necessità, di universalità e di assolutezza non son altro che le indispensabili conseguenze della identità delle rappresentazioni». Cioè, bisogna dire, di quella tale identità, che noi abbiamo introdotto, già nelle rappresentazioni che dovranno essere identificate, tanto per agevolare la futura identificazione; e se l’identico è il concetto, di quella tale identità, che noi abbiamo dovuto mettere nelle rappresentazioni, che per analisi e sintesi spontanea e quasi automatica potessero poi generare il concetto. Perché quelle rappresentazioni noi le investivamo già del concetto, attribuendo loro una qualità, o dicasi pure, vedendole con una qualità, di cui dovevamo pure avere il concetto universale, necessario, assoluto, da quanto quella che l'atto dell'astrazione ne farà saltar fuori.
E qui interviene un'altra teoria che fu il cavallo di battaglia dell'empirismo, dello schietto positivismo corleiano: una teoria, che potrebbe parere una parola, ma una parola che l'Ardigò, se avesse mai letto gli scritti del filosofo siciliano, gli avrebbe dovuto invidiare: una parola tipica e pregnante, in cui c'è tutto l'empirismo: la priorizzazione. «Parola nuova», dice pleno corde l'autore la prima volta che l'adopera, «che debbo usare d'ora innanzi per esprimere un'idea nuova»: ed accingendosi a svelarne il segreto a La priorizzazione dei concetti è una cosa degna di grande studio, ed è di molta importanza»6. Il quale segreto, detto nella forma più semplice e chiara dallo stesso Corleo7, è questo, che «le prime presentazioni, astraendosí per effetto dell'identico e del diverso, prendono il davanti, si priorizzano, divengono tipo e norma di quelle che vengono dopo; poiché è conseguenza ineluttabile del tipo priorizzato, che identicamente si ripeta ed abbia i medesimi caratteri di luì tutto ciò che in quel modo si ripete». Isomma la priorizzazione è la stessa astrazione, in quanto l'astratto o concetto è poi predicato di tutti i complessi rappresentativi o concettuali, che contengano quell’identità astratta tra le loro parti costitutive. E se l'astrazione rileva e mette in luce nel fatto spirituale su, cui si esercita soltanto quello che c'è, la priorizzazione che vuol essere la formazione o genesi dell'apriori, cioè del presunto a priori, c'è pericolo che presupponga appunto l'apriori, che vuoi costruire, e senza di cui l'astrazione, in cui essa pur si risolve, non avrebbe che astrarre. La priorizzazione del Corteo fa il paio, con l'apriori spenceriano che è aposteriori per la specie, ed è apertamente la caratteristica più significativa del suo empirismo.
Non occorre dire che il Corleo rifiuta i giudizii sintetici a priori di Kant; e riduce la funzione giudicativa a un rapporto d'identità, per cui non solo i giudizii a priori, fondati cioè su concetti priorizzati, ma anche i giudizii a posteriori, fondati sulle percezioni empiriche, sono analitici, e non fanno se non mettere in rapporto una parte col tutto.
E il principio d' identità, ormai è chiaro, è per lui la chiave che apre tutte le porte, la legge unica del pensiero, la luce che illumina tutti i misteri. La sua filosofia s'incontra qui, senza nessun rapporto storico, con, la filosofia herbartiana, come superamento della fenomenalità di ogni cangiamento: ma senza questo concetto della fenomenalità, anzi con lo stesso oggettivismo degli antichi atomisti. Per Corleo come per Herbart l'essere non può cangiare; e si deve perciò concepire nella più rigorosa identità. Ma per Herbart il cangiamento è una veduta accidentale, estranea all'essenza propria dei reali; per Corleo invece come per Leucippo e Democrito, se le sostanze elementari sono immutabili, generano peraltro esse stesse, col movimento, tutte le mutazionì. La sua identità non è, come la herbartiana, l'identità degli eleati, che negano il divenire naturale, ma quella appunto degli atomisti che con l’identico moltiplicato costruiscono un reale divenire.
- Palermo, 1890-91, due volumi di cui il secondo rimasto incompleto.
- Da aggiungersi ai citati: I doveri temporanei hanno origine, forza obbligatoria e durata dai doveri assoluti, ovvero alla necessità del progresso in filosofia morale, Palermo, 1863; Il principio d’identità, il giudizio necessario e il giudizio empirico – Il principio stesso d’identità, la sostanza e gli assoluti ontologici: memoria presentata al XII Congresso degli scienziati italiani in Palermo, 1875, negli Atti, Roma, 1879; Le abitudini intellettuali che derivano dal metodo intuitivo, Palermo, 1880; Le comuni origini delle dottrine filosofiche di Miceli, di Malebranche e di Spinoza e loro confronto con quelle di Gioberti e di alcun positivista moderno, in Atti della R. Acc. d. sc. Lett. E belle arti di Palermo, 1884. Dei molti suoi scritti storici, politici e di pubblica istruzione si può vedere l’elenco accurato nel citato scritto di F. Orestano.
- univ. I, 137.
- Sistema, § 8.
- Costrutto siciliano; intendi: Come lui, allo stesso modo di lui.
- univ. I 186-187.
- Sistema, § 22.
IV
Con la logica dell’identità, per cui la cosa non può essere che sé stessa, il Corleo costruisce il suo concetto di sostanza; e con questo concetto distrugge la distinzione stessa di realtà e di fenomeno, come quelle di potenza e atto, e di causa ed effetto; e quindi molte questioni, che a torto avrebbero affaticato in ogni tempo la mente dei filosofi.
La sostanza è assoluta attualità e assoluta unità. Perché, se non fosse attuale, e fosse potenza e atto, e passaggio dalla potenza all’atto, essa non sarebbe identica a sé stessa; e se fosse unità insieme e pluralità, unità che si pluralizza, o unita in atto e pluralità in potenza, come uno e più a un tempo violerebbe del pari la legge della identità, e spianterebbe la logica. La sostanza è pertanto invariabile, perché la variazione implica la contraddizione della potenzialità non attuata; la quale poi non si potrebbe attuare per condizioni proprie dello stesso all’ente, perché in tal caso, l’atto coinciderebbe con la potenza, né per condizioni estranee all’ente, perché allora si supporrebbe che un altro ente potesse mutare sé stesso ed altrui, producendo quelle condizioni che prima non erano e facendole inoltre penetrare nella sostanza dell’ente da sé diverso, ove dovrebbero attuarsi le singole potenze1. «L’identico insomma non potrebbe mai trovare né in sé stesso, né in altro, la ragione per dar nascita al diverso, piuttosto ad uno che ad un altro diverso, a questo prima ed all’altro dopo»2.
Fin qui il Corleo non direbbe diversamente dall'Herbart. Ma il Corleo continua empiricamente: «Noi osserviamo le continue variazioni nei complessi; epperò col dividere e suddividere complessi medesimi arriviamo mentalmente alla impossibilità di continuare cotesta divisione all'infinito; poiché allora [l'aveva anche, detto nei Fluidi imponderabili] la parte ed il tutto sarebbero eguali, cioè egualmente divisibili all'infinito, non potendo esistere un infinito maggiore ed un infinito minore. Così ci persuadiamo della esistenza di enti primi, semplici, indecomponibili per difetto di parti, monadi. Or la ragione delle variazioni, invece di legarla ai complessi, in cui le variazioni stesse si osservano, vogliam noi riferirla a ciascuno di quegli enti primi..... da cui risultano i complessi. Questo modo di pensare sarebbe uguale a quello di chi, vedendo tutta la varietà numerica risultante dalla variazione di cento unità per sottrazioni, addizioni o trasposizioni di esse, vorrebbe credere che la ragione di tutte le varietà fosse in ciascuna delle unità semplici, invece di essere nel loro insieme, nella diversa e variabile loro composizione; vorrebbe supporre che in ogni unità esistesse la potenza di mutare sé stessa e le altre; attribuirebbe insomma ciò ch’è necessaria conseguenza del molteplice diverso a ciascuna delle unità individue che lo compongono»3.
Dunque, pel Corleo sono tanto le unità quanto le combinazioni o complessi delle unità, in cui si risolvono le variazioni. Sono o anzi le unità identiche, perché sono (si osservano) le combinazioni variabili. E poiché la combinazione vale come il complesso o somma o collezione delle unità elementari, Sostanze queste, sostanziale anche quella. «L'uno è sempre uno, sempre lo stesso uno, la pluralità è identica alla collezione delle unità, non è una cosa diversa da essa, ne è la produzione di una sola di esse» (§ 86). Non potrebbe essere più evidente il contrasto tra la fenomenalità del cangiamento herbartiano e la sostanzialità della variazione cor1eiana: contrasto, che torna a confermare la diversa posizione, speculativa dei due pensatori, metafisica e veramente speculativa per il tedesco, empirica e naturalistica per l'italiano. Il quale non muove propriamente dalla sostanza, ma dal fenomeno trattato come sostanza. Dal fatto osservato del variare, non saputo spiegare che per combinazione di un determinato numero di unità elementari: secondo le suggestioni che certamente ei dovette ricevere dagli scritti del conterraneo Benedetto D’Acquisto, che già aveva anche lui, «riconosciuto – lo avverte lo stesso Corleo4 la impossibilità della divisione all’infinito della materia, per la impossibilità di esservi (sic) un infinito maggiore ed un infinito minore, mentre per divider sempre bisogna necessariamente questa progressiva diminuizione di parti e di sottoparti»: e spiegava anche lui la natura, creata da Dio, come la combinazione di «primi principii, realtà semplici, indecomponibili fisicamente, invariabili in qualunque stato cui si considerano, sia nello stato di isolamento, sia in quello di composizione e decomposizione»; insegnando già che «ogni combinazione de’ principii, nella quale consiste la natura dell’essere che ne risulta, presenta due manifestazioni, cioè quella di quantità e quella di qualità: la quantità è relativa al numero de’ i principi che si combinano; la qualità consiste nella peculiarità della combinazione»5.
Identico il fenomeno, come manifestazione della sostanza, alla sostanza stessa, come somma degli atti delle unità elementari, e del pari identico, e per la stessa ragione, l’effetto alla causa: la quale consta degli elementi concorrenti nella norma di atti, che è l’effetto. Che se l’effetto pare talvolta altro dalla causa, la legge della identità è sempre rispettata; e il risultato è la somma di identici; poiché quando A è causa di B, allora effettivamente A e B devono far parte d’un sol tutto, la cui reintegrazione fa essere B come fa essere A, Fa essere cioè il cangiamento, che riesce sempre somma di unità. Le «risultanze continuamente diverse, considerate distintamente e nella loro successione di prima e dopo, rappresentano le cause e gli effetti tra loro distinti, ma riguardate nel loro insieme o nel loro risultamento, sono tante concause che s’identificano col loro effetto totale, e col tutto che da loro stesse risulta»6.
Ora, se l’effetto non è altra cosa dalla causa, se il fenomeno non è la manifestazione d’un noumeno, se non è l’altro di una potenza distinta da esso, l’ideologia è la stessa ontologia: anche il pensiero, come ogni altro cangiamento, è somma di atti sostaziali, o sostantivi, come dice il Corleo. Il quale per tal modo non dubita punto di aver superato per sempre il soggettivismo, che consisterebbe, secondo lui, nel misero circolo vizioso di ritenere per certo «che il plurale fenomenico, qual è il pensiero, non sia un insieme di veri elementi, ma sia un fenomeno vuoto, di cui resta a cercare la causa o le cause al dì fuori di lui». «É il falso supposto», egli aggiunge, «che reagisce sopra sé stesso, come se dicesse: il 100 è egli composto di cento unità, o è una vuota apparenza, o è il prodotto di una sola unità? Per dir questo, bisogna supporre che il 100 possa realmente non esser 100, ma appariscenza, di 100, o prodotto di una sola unità». Due assurdi, dato l'inconcusso principio d’identità.
Identico ragionamento, - senza la vantata rettificazione dell’idea di sostanza e la pompa del principio, d'identità, ma pur presupposti quella e questo, - al ragionamento onde il realismo empirico dei positivisti, supponendo che il pensiero possa essere un risultato di attività concorrenti che non sono pensiero, e devono valere come oggetto del pensiero, e però nel pensiero (ossia appunto come pensiero), trova evidente che esso pensiero sia realisticamente valido da quanto la realtà che lo produce; e non avverte che la stessa realtà onde quel realismo costruisce il valore del pensiero, non può aver valore, se non l’ha prima il pensiero: e che, insomma, ridotto il pensiero a un fatto, nessun fatto è concepibile, e tanto meno quindi lo stesso pensiero. Il Corleo, con la sicurezza dei vecchi dommatici, non pone mente che la sua equazione formale 100 = 100, in tanto prova che il pensiero è identico alla somma degli atti sostantivi, dalla cui combinazione risulta, in quanto esso risulta dalla combinazione di un certo numero di atti sostantivi, che non sono essi stessi pensiero, e non sono quell'unità che é, il pensiero. Non s’accorge e non può accorgersi che dentro al circolo c'è qui non il soggettivista, ma il filosofo dell'identità. Non può accorgersene, perché, ripeto, egli muove dai fatti, dall'osservazione dalla certezza immediata di quel mondo, per cui il pensiero non è esso stesso se non un fatto, e però la negazione del pensiero; il mondo della natura, il mondo saldo e incrollabile del positivista.
E così anche il Corleo fa della sensazione una funzione speciale risultante da organi adatti a compierla; «i quali non potrebbero pur modificarsi e produrre da se stessi i cangiamenti e le diversità della sensazione medesima; se diversa non fosse da una parte la loro conformazione, e se dall'altra diversamente non venissero impressionati dagli agenti esteriori». Onde, «subbiettivamente considerata, la sensazione non è che la risultanza de' suoi stessi organi, poiché l'effetto è identico con l'insieme degli elementi che lo costituiscono». Dall'altra parte «se la sensazione è un risultato, un insieme di sostanze-azioni, come in generale ogni fenomeno, e se gli elementi del risultato sono atti intransitivi, immutabili, incapaci di cangiare sé stessi né altri, egli è chiaro che tutti i cangiamenti subbiettivi organici della sensazione debbono avere fuori degli organi il tanto di ragione al rispettivo cangiamento. In altri termini, la sensazione è una larga risultante delle azioni sostanziali esterne o oggettive o delle azioni sostanziali interne all'uomo o subbiettive»7. Tutta, insomma, la solita mitologia della psicologia empirica.
Occorre dire che tutte queste sostanze elementari del mondo sono la stessa materia, battezzata o no per tale, dei positivisti? Il Corleo, chiuso nel suo formalismo matematico, non sapendo delle sostanze, se non che sono unità equivalenti, componibili e scomponibili, tutte reali in quanto non si possono pensare altrimenti, non sa propriamente dell'essenza loro più di quanto l'Herbart sappia del was de' suoi reali;- egli è costretto dalla stessa posizione del suo problema empirico - che è la spiegazione del cangiamento, dati gli elementi che costituiscono la realtà - allo stesso agnosticismo di tutti i positivisti, che, uscendo fuori dal reale (che è in loro) e mettendosi a riguardo ab extra, non possono di certo vederne più della superficie. Ma la parte assegnata da lui alle sue sostanze, inerti e bruti elementi di un meccanismo tutto estrinseco, è, come la natura meccanicisticamente concepita da tutti i positivisti, schietta materia. Ed egli infatti sente che la sula concezione del pensiero come risultante dalla somma delle sue sostanze, sarebbe materialistica: sarebbe, se egli non confidasse di tagliare il nodo, onde egli stesso si viene strettamente avvincendo nel mondo buio dell'atomismo.
Egli si fa un grande merito di fare della filosofia universale una universale matematica: ragguagliata la realtà a un numero determinabile, se non determinato, di unità elementari, ciascuna identica costantemente a sé stessa ed equivalente (quantitativamente) a tutte le altre; numero perciò divisibile in quantità aventi tra loro rapporti costanti e proporzioni fisse8. Tutto lo sforzo e il valore della scienza è, dunque, per lui risolvere le qualità in quantità (l’opposto di quel che pensava il Leibniz); scompaginando tutte le qualità onde ciascuna cosa è sé stessa, e ragguagliando tutto l'universo, a un sol confine, dove non regga altra legge che il numero: che è appunto il più logico assunto del materialista.
Intanto, è veramente spiegabile con questo solo criterio quantitativo lo stesso cangiamento meccanico? Nella Filosofia universale, come nei Fluidi, movendo dal suo concetto di sostanza, il Corleo nega il non-essere di Democrito, lo spazio vuoto che rende possibile in se il movimento degli
atomi, e il loro accozzamento, donde il divenire naturale. Anzi, il vuoto, la mancanza dei contatti, renderebbe secondo lui impensabile il movimento, come cangiamento spontaneo delle singole sostanze. Queste non si possono pensare se non contigue tutte quante, e spostatili soltanto per effetto del variare dei loro rapporti. Lo spazio pertanto è lo stesso mondo, gli esseri che lo compongono, le loro relazioni di contatto, la loro mutua sostituibilitá: finito come il numero delle sostanze elementari, onde consta il mondo.
Orbene: posta quella che il Corleo dice prima e fondamentale legge cosmica, dell'aggregazione continua; se la massa mondiale è un insieme compatto di monadi materiali, prive di qualsiasi potenzialità, senza interstizio di sorta, come si supera quello stato di universale equilibrio e quiete, in cui pare che tutta la massa venga in questo modo a comporsi? La soluzione del Corleo è questa:
«Dovendo l'aggregazione esser continua e non potendo essere infinito il numero degli elementi, me per sé stesso dovendo essere numero determinato e preciso, per quanto pure sian limitale rispetto ad esso le nostre conoscenze, è ben certo che debba per necessità esservi una periferia, avente una figura od un'altra (non importa), ed in corrispondenza uno o più centri della periferia stessa». E il numero è determinato e preciso perché il tutto altrimenti, come s'è visto, non sarebbe maggiore delle parti in cui si può dividere. «Or non sono le stesse le condizioni delle singole sostanze che sono alla periferia, e di quelle che sono al centro, di quelle, che sono ad un terzo, a metà, a due terzi di raggio, e via via. Non è sola differenza dì distanza di ciascuno degli elementi rispetto al centro, ma ciascuno è in aggregazione attiva con tutti gli altri suoi vicini, e quindi ognuno porta su di sé la somma o la risultante maggiore o minore degli altri, in ragione che sia più vicino al centro, ossia da esso più lontano. Posto il contatto attivo universale dì tutti gli elementi mondiali, i loro raggi, convergendo verso il centro, si assommano, si addensano necessariamente, come al contrario sono meno numerosi e meno densi alla periferia. Onde è ben minore la somma dei
contatti attivi che porta su di sé un elemento, il quale si trova alla periferia, di quella che porta su di sé un altro simile elemento, il quale sia a metà di raggio, presso al centro, o al centro stesso»9.
Non discuto la solidità di tutta questa rappresentazione, che è una ipotesi come tutte le altre non difficili alla fantasia mitica dei naturalístì, condannati, eterni Sosifi, a costruirne e ricostruirne di continuo. Incontestabile mi pare che qui il Corleo non tiene fede egli stesso al decantato principio d'identità (al quale già, per sé solo non c'è chi possa tener fede, e intanto pensare). Egli finora ci aveva parlato di sostanze, che sono unità e fan numero: ossia di quantità equivalenti. «Ogni unità elementare», egli diceva, «è identica costantemente a sé stessa e vale quanto un'altra». E questa era è la base della matematicità dell’universo. Inoltre, questa quantità doveva essere, per essere quantità assoluta, la risoluzione d’ogni qualità. Che altrimenti la scienza non sarebbe stata più il calcolo delle proporzioni quantitative, ma anche la ricerca delle qualità proprie delle varie sostanze, o, per lo meno, questa e quello. Qui invece, per mover le acque di quell'eterna bonaccia in cui gli si rappresentava all’immaginazione l'oceano delle sue sostanze elementari, egli comincia a introdurre in ciascuna di esse qualche cosa che ne distrugge la identità primitiva, sovverte la concezione meramente quantitativa del loro molteplice, e intacca quindi profondamente, anzi distrugge la matematicítà della Filosofia Universale. Infatti, ciascuna delle sostanze della massa, in cui solo è possibile che essa venga concepita, è diversa dalle altre; è diversa bensì, per la posizione, che non è pel Corleo un carattere interno della sostanza; ma non è interno perché il Corleo crede di avere staccato quello che non ha punto staccato. Giacché se la sostanza non si può pensare se non come parte di un tutto, avente una periferia, e quindi o come più vicino al centro, o come più vicino alla periferia, può essere estrinseca alla sostanza una determinata posizione, ma non una posizione. E vedemmo già nei Fluidi imponderabili come, a differenza dell'Herbart, Il Corleo non disgiunga dal concetto dei suoi reali la loro mutua correlatività. E se le sostanze sono diverse peri loro rapporti di posizione, ognun vede che non è vero che il cangiamento, a cominciare dal moto spaziale, sia un rapporto di posizione proveniente dall’aggregazione delle monadi, se non a patto di dire insieme che le monadi nel loro essere determinato provengono dai rapporti di posizione. Che è come dire che l'essere non è l’identico, l’essere non è la monade elementare, ma l’essere è il cangiamento, in cui le monadi non si possono distinguere l’una dall'altra. O altrimenti: le monadi non si sommano, ma si organizzano coi loro caratteri differenziali; e il mondo non si divide, perché dividendosi muore, come ogni cosa che è viva per un principio che l'unifica inscindibilmente.
V
Ma valga quel che può valere la matematica del Corleo, certo essa rientra nell'intuizione schiettamente positivistica; e non ne esce se non per distrugger sé stessa. Giacché essa ne esce certamente, ma cessando di esser matematica, cessando di esser la particolar filosofia del Corleo, scotendo le stesse fondamenta dei presupposti positivistici. Ne esce per imporre alla meccanica psichica un cappello spiritualistico, e per preporre alla meccanica cosmica una causalità teistica: con un così evidente segno del distacco tra l'intuizione naturalistica fondamentale e l’arbitraria integrazione metafisica, da render testimonianza, come s'è di sopra accennato, della insufficienza assoluta di quella fondamentale intuizione rispetto ai problemi maggiori della filosofia.
Il Corleo non sente, urgente almeno, il bisogno dello spirito, della libertà che è propria di esso, per tutta la ricostruzione dell’attività teoretica; ma, quando passa alla pratica, e sente che spiegare col 100 = 100 il prodursi del volere sarebbe un aggiogarlo alla falsità, dà addietro. Sente che quella materia, per cui egli ha insegnato che 100 – 1 = 99, 100 + 1 = 101, «è sempre fatale in tutte le sue risultanze». Come fare? In matematica non si ammetto opinioni, dice Kant. E allora, sit pro ratione voluntas: e il Corleo fa 100 + 1 = 120. Leggiamo il § 337 del Sistema:10.
«Se questo è il concetto vero della fatalità, non può la libertà altro che la plusvalenza di alcuno degli elementi del risultato sopra tutti gli altri, di guisa che il risultato non sia esattamente identico alla somma numerica degli elementi che lo compongono; ma perché alcun di loro vale come atto sostantivo più degli altri, la risultante corrisponderà alla natura medesima dei componenti, cioè con un numero minore di elementi, per la plusvalenza di uno di essi, si avrà una somma di azione maggiore, non corrispondente al numero. Questa plusvalenza, se veramente ci fosse, dovrebbe comparire con ispecialità nel caso che il risultato venisse a diminuire ne' suoi elementi, rimanendovi pero quello che vale più degli. altri... Se vi ha un gruppo di tot elementi, di cui 100 tutti di egual natura o di eguale atto sostantivo, ed uno che valga nel suo atto sostanziale quanto valgono venti di essi, al quale daremo il nome di a, si avrà allora un risultato numerico 101, ma nel complesso degli alti sostanziali si avrà 100 + (a = 20) = 120. Or se dal gruppo si toglieranno 60 rimanendovi a, si avrà il numero di elementi 41, ma la risultanza attiva sarà di 40 + (a = 20) = 60, cioè il risultato per una terza parte sarà proprio di a, mentre nel precedente risultamento l'a non ci aveva che la proprietà di un solo sesto. Or se mai da cotesto gruppo numerico 41 si toglieranno tuttavia altri 30 elementi, rimanendovi sempre a, si avrà numericamente 11, ma nel complesso sostanziale si avrà 10 + (a = 20) =30. Allora due terze parti di quel complesso apparterranno ad a. Così ancora, se la diminuzione degli altri elementi avanzasse, la plusvalenza dell’a si renderebbe sempre più manifesta, ed il complesso: sarebbe composto dell'azione sua sostantiva in massima parte; azione sostantiva, ch’è sempre identica a sé stessa, senza potenza né cangiamento alcuno, ma che per la sua plusvalenza, nella mutazione decrescente del risultato, dà prodotti non proporzionali al numero».
Questa diminuzione degli elementi del complesso materiale funzionante col progressivo aumento proporzionale di una speciale funzione il Corleo, riflettendovi bene, la trova non solo nella libertà del volere, che si vien liberando dalla causalità naturale, ma nell'esercizio dell’astrazione funzione, secondo lui, privilegiata dell’uomo tra gli animali, che non cresce con la somma, ma con la divisione delle percezioni. Ma è evidente che la materia per cui 101 può essere 120, e 41 può essere 60 e 11 può essere 30 non è più matematica. Perché quell’a, se non è 1, non può essere né anche 20 e la plusvalenza fosse meramente quantitativa (20-1), non si potrebbe parlare più di un’unità plusvalente, ma di 20 unità equivalenti. E la matematica sarebbe restaurata facendo 100+20 =120, senz’altro. Il 20 qui pel Corleo non è più 20: è un venti che è uno, ossia uno tutto indivisibile. E però non è più un numero ragguagliabile al 100; non è un numero, non è quantità, è qualità irriducibile a un’altra qualità. E allora non solo lo spirito è qualità, ma anche la materia. E la spiritualità, sovrapposta al materialismo, lo schiaccia. E la matematica al contatto della qualità svanisce.
Passiamo a Dio. Il mondo è pluralità determinata, in aggregazioni diverse, come s’è visto, e quindi in movimento, che importa passaggio da uno stato all’altro, e coincide col tempo. Ora tempo significa prima o poi, successione di rapporti, che devono rimontare a un primo rapporto. Perché se non ci fosse il primo, non ci sarebbe il secondo, il terzo, mancherebbe la successione; e il tempo si confonderebbe con l’enternità, dove non c’è distinzione di momenti, e il luogo del numero si ha l’uno. Il tempo è finito e numerabile, e però ha principio e fine. Quindi il moto, che è lo stesso tempo, non è eterno. Né può essere eterna la materia, la quale, una volta posta, non può non muoversi, essendo quella pluralità aggregata che s’è detta. Si dirà che la materia, non non eterna in quanto pluralità, è eterna nella sua radicale unità, donde sgorgherebbe la pluralità? Ma questo contrasta all’identità della sostanza. L’uno non può essere mai che l’uno; e il molto non può derivare da esso. Dunque? Il molto è un fatto, e poiché non è eterno, ha dovuto cominciare; cominciare significa esser preceduto da altro; il mondo, dunque, è stato preceduto da altro, che non è cominciato, ma è eterno; e che non può esser molto, ché altrimenti sarebbe cominciato anch'esso. Il molto, anche pel Corleo, come pel D'Acquisto e tutti i leibnziani della scuola monrealese, instaurata dal Miceli, il molto finito, perché numerabile, e temporale, è preceduto dall'Uno eterno, che lo fa essere, senza farlo partecipare in modo veruno del proprio essere, perché la partecipazione importerebbe un cangiamento impossibile nella sostanzialità dell’Uno; e insomma, lo crea dal nulla. Ecco il creatore, ecco Dio.
Anche qui io non voglio cercare i sofismi che viziano l'argomento del Corleo: mi limito solamente a notare che la filosofia dell'identità, coi suo matematicismo, in questo problema fallisce: non per colpa sua, beninteso, ma di quella realtà, che veramente, fatti bene i conti, non è identica a sé stessa né nel tutto, ne nelle sue parti singole, le quali poi solo a tal patto sarebbero numerabili11. Se i molti fossero nient'altro che molti, e l'Uno nient'altro che uno, se le sostanze tutte non fossero se non unità, come potenze attuate, reali semplici, i molti essendo il numero x, i molti e. l'Uno sarebbero x + I: ossia non mondo e Dio, ma un numero, il mondo solo. Perché il mondo sia altro da Dio, l'Unità di questo e la molteplicità di quello non devono essere sommabili: non devono essere quantità, ma qualità. Cioè non basta che l'Uno non sia molti, ma ciascuno dei molti non dev'essere molti: ossia moltiplicabile o sommabile; ciascuna monade mondana non dev'essere un'unità indifferente qualitativamente, ma un’unità di una certa qualità: di quella qualità di cui ci ha molte monadi. La posizione, insomma, privilegiata di Dio rispetto al mondo, di quest'Uno che non è unita matematica, reagiste sugli uni materiali e spirituali del mondo, qualificandoli per differenziarsene: e col qualificarli, li sottrae alla mera definizione quantitativa e li fa quindi sfuggire alle prese della filosofia dell'identità.
O mondo matematico senza Dio. O Dio senza matematica, né in sé ne fuor di sé. Incipis numerare, incipis errare.
Giovanni Gentile
- Sist.,§ 76.
- Sist.,§ 77.
- Ivi, §§ 78-79.
- Sist., § 88 , p. 54 n.
- B. D’Acquisto, Della scienza univ., Palermo, Lao, 1850, §§ 512, 30.
- Sist., § 100.
- Sist., §§ 256, 257, 261. Cfr§ 114.
- Ivi, § 90.
- Sist., § 149.
- Cfr. il cap. VIII dell’antropologia nella univ., II 291 sgg.
- Vedi univ., §§ 230-236; Sistema, §§ 127-128, 229-233.
- Dettagli
- Scritto da Carlo Oreste Zuretti
- Categoria: Conferenze
- Visite: 2731
Conferenza tenuta il 4 dicembre 1910, pubblicata su Annuario della Bibl. Fil., vol. I, 1912, pp. 202-204
Le più antiche tragedie elleniche della metempsicosi si trovano nei poemi omerici che contengono se non tutti, come si affermò esageratamente, certo molti germi, che poi si svilupparono nell'arte e nella speculazione greca. - Il mito di Circe, che compare nell'Odissea, è il più antico esempio di metempsicosi - o, qui forse più esattamente, m e t a s o m a t o s i - che si possa trovare. Per opera della bellissima figlia del Sole gli uomini, pur mantenendo la loro psiche, vengono trasformati in quei bruti, che più e meglio corrispondono alle loro qualità. - Però questa trasformazione non è contraddistinta dalla morte, e non è neppure completa, giacché permangono più i caratteri propriamente umani; inoltre, se in potenza è possibile a tutti gli uomini, in atto però è solo di quelli, che cadono, nelle mani della maga.
Se poi passiamo ad esaminare la satira di Simonide di Amorgo contro le donne vi troviamo come caratteristico prima di tutto non un abbassamento dell'umano al belluino, anzi una elevazione dal belluino all'umano, per quanto riservata solo alla donna, e poi la derivazione animalesca dell’anima e del corpo insieme.
In Senofane si trova un accenno esplicito ad una vera e propria dottrina filosofica della metempsicosi attribuita a Pitagora. Ma generalmente nella poesia si restò per molto tempo ad una forma molto elementare di questa dottrina, che non usciva dai limiti di una semplice credenza popolare, come si ricava per esempio dal monologo di Cratone nella Theophorumene di Menandro (framm. 223).
Se non che già in parecchi miti entrava come elemento costitutivo una trasformazione da forma umana a belluina o un innesto dell'una sull'altra (Io, Gerione, Proteo, i Centauri, la Sfinge, Atteone), ed è interessante osservare che spesso questi miti ci riconducono all'Egitto: né ciò deve far meraviglia, poiché Erodoto (II, 123) attribuisce la enunciazione della teoria della metempsicosi agli Egiziani, dai quali l'avrebbero ricevuta i filosofi greci.
Fra questi Platone svolse compiutamente tale dottrina e ne fece un elemento essenziale del suo sistema.
Chi esamini la dottrina come è trattata prima nel Fedro quindi nel Timeo, ne può agevolmente avvertire i punti di contatto con quella egiziana, com'è data da Erodoto, e osservare che le esposizioni dell'uno e dell'altro dialogo si compiono a vicenda, e vengono insieme integrate da quanto è qua e là accennato in proposito negli altri dialoghi platonici. Donde è pur dato di ricavare che Platone professò costantemente questa dottrina, che attraverso alla scuola pitagorica perveniva a lui dall'Egitto: infatti, oltre alle parole di Erodoto, abbiamo in proposito la testimonianza medesima di Platone, il quale fa esporre da un Pitagorico (Timeo) questa dottrina, e nel Timeo stesso e nel Crizia, che n’è la continuazione, insiste su elementi e leggende egiziane o ritenute tali. Egli trova questa dottrina consona al suo sistema filosofico, vi scorge anzi il culmine e il coronamento dell'opera; ivi trova ciò che spiega tutte le altre teorie filosofiche e spiega il mondo nel tutto e nelle parti, massime e minime, nel presente e nel passato, nell'essere e nel divenire, nella materia e nello spirito. Nessuna meraviglia dunque ch'egli l'accetti, qualunque ne sia l'origine, e che vi introduca probabilmente elementi propri. Ma questa dottrina di che natura è? Se osserviamo che i particolari e il fatto stesso vengono affermati ed esposti non con dimostrazioni, ma come rivelazione, e che anzi si dichiara impossibile la dimostrazione, risulta evidente che per Platone la metempsicosi è non già dottrina semplicemente filosofica, ma anche vera e propria credenza religiosa.
- Dettagli
- Scritto da Guido Ferrando
- Categoria: Conferenze
- Visite: 1101
Conferenza tenuta il 3 luglio 1910 e pubblicata sul Boll. della Bibl. Filos. di Firenze, a. 111 (1911), pp. 369-372, e su Annuario della Bibl. Fil., vol. I, 1912, pp. 195-200
Quanti hanno letto Emerson, e non sono molti in Italia, sanno che il fascino e l’efficacia grande che egli esercita sull’animo dei suoi lettori, è dovuto più al suo carattere, che alla sua cultura, al suo ingegno, alla sua filosofia. Per poter quindi comprendere e valutare esattamente l’opera sua, è necessario conoscere l’uomo, oltreché lo scrittore e ricostruire la sua figura morale e spirituale, di cui gli scritti sono una diretta espressione. Ma il carattere di Emerson sfugge ad ogni nostra determinazione: la purezza della sua anima fu tale che ci impedisce di discernere le linee della sua persona. La sua modestia, uguagliata solo dalla serenità inalterabile del suo temperamento, lo trattenne sempre dal pensare e dal parlare di se stesso e non permise che altri ne parlasse. Quest’oblio completo della propria persona, gli veniva dall’amore per la perfezione morale che lo distolse quasi del tutto dagli affetti umani. «Amo l’uomo, egli scriveva nel suo Giornale, e non gli uomini». Della vita non seppe e non volle vedere che il lato bello ed immortale, e visse così in un mondo di una realtà soprasensibile. Non conobbe le lotte terribili tra il bene e il male, e fu esente da quegli appetiti animali a cui soccombono talvolta anche gli spiriti più elevati. Mistico per temperamento e per razza, la natura della sua intelligenza fortificò in lui la tendenza del suo carattere; ed egli predilesse, tra i grandi pensatori, quelli che si innalzarono alla verità per virtù d’intuizione. Però, a differenza degli altri mistici, era dotato d’un solido buon senso o possedeva una vasta cultura, sì che gli riuscì di evitare ogni eccesso e ogni esaltazione; il suo misticismo non si perde in vuote contemplazioni, ma conduce all’azione ed esercita un’efficacia pratica sull’individuo umano.
Spirito mistico e positivo a un tempo, amante del divino, ecco quale ci appare Emerson quando si cerca di determinarne la fisionomia morale; ma noi sentiamo che questa determinazione è puramente esteriore e che l’anima sua ci sfugge, rimane incomunicabile.
E allora sorge in noi il dubbio che anche l’opera sua, manifestazione del suo io inafferrabile, sfugga ad ogni nostra analisi, si sottragga ad ogni valutazione teorica. Questo hanno creduto e sostenuto la maggior parte dei suoi critici e ammiratori: i primi perché hanno giudicato il suo pensiero troppo confuso e contraddittorio per esser analizzato e valutato razionalmente: gli altri perché hanno ritenuto che criticare Emerson significa profanarlo, dal momento che egli non fu un filosofo o uno scienziato, ma una grande anima, le cui visioni ed ispirazioni hanno valore per la loro profondità e sincerità e non per il loro contenuto.
Ma poiché Emerson non fu né un pazzo visionario né un idiota vaneggiatore, è evidente che il suo pensiero, per quanto vario e contraddittorio, debba riposare sopra alcuni principii fondamentali bene accertabili; ed è dovere di una critica imparziale porre in rilievo questi principii, in cui si compendia tutta l’essenza dell’opera sua. Emerson coi suoi scritti si propone un duplice scopo; e come nel campo morale, da un lato, frusta a sangue gli imbelli e gli accidiosi e dall’altro suscita nell’animo nuove energie celebrando la vita interiore e mostrando tutte le possibilità della natura umana: così, nel campo teoretico, dimostra da una parte l’impotenza della ragione a risolvere il problema della vita, e dall’altra afferma la necessità di rimettersi allo spirito, che solo può guidarci alla visione suprema del vero. La verità non è frutto di una ricerca intellettuale, ma figlia dell’ispirazione: non è una teoria, ma uno stato d’animo; non può esser dimostrata, ma sentita, e solo da quelli il cui spirito è puro, perché essa ha un’identità assoluta col bene. Per contemplarla, bisogna abbandonarci alle nostre ispirazioni, senza preoccuparci se esse variino e talvolta si contraddicano, perché nessuno stato d’animo può racchiudere tutta la verità, e il variare continuo delle nostre intuizioni ci insegna a trovare l’eterno nell’effimero, l’unità nella diversità. Quando si scende nelle profondità della nostra anima per cercare l’origine di queste ispirazioni, noi veniamo in contatto con un principio eterno, immutabile, supremo, che chiamiamo spirito; esso è l’unica realtà dell’universo, ed è ineffabile, perché nessuna parola serve ad esprimerne la pienezza.
Nulla può esistere fuori dello spirito, nulla può sottrarci alla legge che domina tutte le cose: né questa concezione è fatalistica, perché l’uomo, in cui lo spirito si fa cosciente, ha la facoltà di riconoscere volontariamente l’onnipotenza della legge e di attuarla così liberamente.
Se lo spirito è l’unica realtà, il male non può esistere sostanzialmente. Esso non è che privazione, e quindi illusorio: e neppure esiste il peccato, e l’uomo deve negarlo per affermare solo il bene, che è l’unica manifestazione reale della vita suprema. Ma gli uomini hanno smarrito la via del bene e, per ritrovarla, debbono tornare alla natura; la natura, che è il tempio della divinità, l’organo di cui lo spirito si serve per rivelarsi all’individuo e ricondurlo a sé. La natura sotto l’infinito variare delle sue forme è sempre identica a se stessa e ripete sempre due leggi fondamentali: quella di compensazione e quella del miglioramento progressivo. Per la prima legge nessuno può sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni, perché ogni atto che compie segna un progresso o un regresso nella sua vita interiore; per la seconda, l’universo tende al suo perfezionamento mercé la collaborazione concorde di tutte le sue parti. L’individuo umano viola sempre questa legge e tenta di far servire il mondo ai suoi scopi egoistici; ma la natura procede per la sua via e a furia di dolorose e tragiche esperienze insegna all’uomo quanto sia vano ogni desiderio personale dinanzi alle infinite possibilità di un’ascensione senza limiti. E allora, quando ci sorge dinanzi la visione dell’unica vita universale dello spirito, noi ci abbandoniamo tutti con un atto d’amore e di fede a questa realtà suprema, lieti di annullarci in essa. Né più ci turba il pensiero della vita futura, il problema della nostra immortalità, perché comprendiamo che per noi ha valore l’attimo che fugge e non i secoli che verranno, e che quando si compie tutto il nostro dovere per la profondità stessa della nostra vita morale noi si entra a far parte dell’eterno.
Questo è il fine a cui dobbiamo tendere; e a facilitare all’uomo il raggiungimento di esso, Emerson ha dedicato la parte migliore di se stesso e dell’opera sua. Egli è stato un grande rinnovatore della coscienza umana e ha mostrato all’individuo la via della perfezione con la dottrina della fiducia in se stesso, la Self Reliance, che costituisce, secondo i suoi ammiratori, il Vangelo della vita moderna. Questa dottrina così famosa, che pochi hanno intesa, non è altro in fondo che l’applicazione delle leggi spirituali alla vita dell’individuo: per Emerson infatti l’aver fede in sé, il ribellarsi alla morale piccina e livellatrice della società contemporanea per affermare la propria indipendenza di carattere, il proprio io, non è atto d’orgoglio, ma è un riconoscimento della realtà suprema dello Spirito, perché l’io a cui ci appoggiamo, non è altro che la più alta manifestazione della vita divina.
Questa teoria della Self Reliance, Emerson l’applica anche alla vita famigliare e politica; e dimostra come questo principio dell’obbedienza al divino formi l’unica base su cui si possa innalzare il solido e armonico edificio della famiglia e dello stato. Per Emerson l’etica e la religione si identificano: il Vangelo ha valore solo in quanto è manifestazione della legge morale. Egli non ammette la divinità di Cristo e riconosce in tutti gli individui le stesse infinite possibilità di perfezione spirituale; e invero dinanzi alla grandezza della legge, in faccia all’unica Realtà, che sono le persone, se non raggi della luce divina?
Queste, schematicamente esposte, le idee di Emerson. Il criticarle, il mostrarne le grandi lacune, è facile impresa; ed è anche utile, purché la critica sia mantenuta entro i limiti imposti dalla natura dell’opera emersoniana. Però, quando noi abbiamo messo in luce le deficienze e gli errori del pensiero di Emerson, dobbiamo riconoscere onestamente che non abbiamo colpito nel segno: la nostra critica si appunta su idee che, isolate o tolte da quell’atmosfera d’intima vitalità che le circonda, perdono ogni valore spirituale; ma non tocca l’uomo, lo spirito vivente; questo, che nessuna critica può diminuire o distruggere, solo l’anima e il cuore sanno comprenderlo e amarlo.
- Dettagli
- Scritto da Federico Raffaele
- Categoria: Conferenze
- Visite: 1507
Comunicazione letta alla Biblioteca filosofica il 27 nov. 1910, pubblicata su Annuario della Bibl. Fil., vol. I, 1912, pp. 91-112
La storia delle teorie dell’evoluzione è davvero, per chi la sa leggere con animo sereno e, vorrei dire, con spirito di umiltà, una chiara dimostrazione della inanità dei nostri sforzi quando, non contentandoci di conoscere gli aspetti delle cose, ne vogliamo indagare le cause.
Oramai la graduale evoluzione delle forme organiche sul nostro pianeta è generalmente ammessa, fra gli uomini d’una certa cultura, come un fatto quasi altrettanto indiscutibile quanto quello della rotazione della terra intorno al sole, se bene sia ben lungi dall’essere dimostrato, né forse dimostrabile, con pari rigore.
Questa opinione si ritrova, è vero, in qualche filosofo greco e fa capolino qua e là in alcune opere del secolo XVII e XVIII; ma soltanto nel secolo scorso essa cominciò a prender forma di ipotesi scientifica.
Come fondatori del moderno evoluzionismo sono generalmente riconosciuti il Lamarck, il Darwin e il Wallace. Si deve infatti all’opera di questi tre grandi naturalisti, e sopra tutto all’incredibile successo dell’Origine delle specie tutto il grandioso movimento evoluzionistico della biologia moderna.
Il Butler ha ragione di voler rivendicare ad alcuni predecessori e specialmente al Buffon il merito di avere esplicitamente affermato il principio della evoluzione; ma, se la originalità delle idee del Darwin ne viene alquanto scemata, resta pur sempre il fatto innegabile che soltanto dopo la comparsa dell’Origine delle specie, l’evoluzione degli esseri viventi divenne materia di discussione scientifica e di ricerca metodica.
Le vicende del Darwinismo sono note a tutti. Al trionfo, vivacemente contrastato in principio, ma affermatosi poi con una rapidità che forse non ha confronti nella storia delle scienze, successe, verso la fine del secolo in cui il darwinismo era nato, una energica reazione. Lo spirito umano, forse stanco della tirannia, che la nuova teoria gli aveva inflitta per quasi mezzo secolo, si ribellò quando poteva parere completamente soggiogato.
Se fra il 1870 e l’80 era tenuto per retrogrado o corto di mente chi non abbracciasse incondizionatamente la nuova religione − ché tale davvero era diventato il darwinismo per opera degli ardenti suoi apostoli, − sul finire del secolo XIX divenne sospetto di imbecillità congenita ogni darwinista convinto.
L’opera di Carlo Darwin, paragonata già dagli entusiasti a quella del Newton, fu giudicata una colossale mistificazione da un moderno naturalista; un altro definì il darwinismo una malattia inglese da cui era urgente guarire. Articoli e volumi sul tramonto e sulla fine del darwinismo presero il posto degl’innumerevoli scritti che avevano propalato e commentato la “teoria della discendenza” come il libro sacro della biologia.
Oggi chi, senza preparazione, volesse formarsi un giudizio leggendo i tanti libri ed articoli pubblicati pro e contro il darwinismo, rimarrebbe non poco imbarazzato. Mentre in alcuni scritti dei più reputati autori si trova l’affermazione che alla teoria del Darwin può appena concedersi un posto nella storia delle scienze come a un episodio oramai esaurito, si stampano ancora oggi ponderosi Trattati di Darwinismo, nei quali centinaia di pagine sono dedicate a una minuziosa disamina della teoria e questa sembra più viva e vera che mai e tale da trionfare ancora contro tutto e contro tutti.
Come mai, si chiederà l’ingenuo lettore, possono sussistere così opposte opinioni? e dopo tante e così verbose discussioni non può sapersi se la teoria del Darwin sia vera o falsa?
Eppure questo curioso stato di cose era da aspettarsi fin dal primo apparire dell’Origine delle specie. Perché questa teoria della discendenza, apparentemente fondata sui fatti osservati, era in realtà imperniata su due incognite: la variabilità e l’eredità. E queste incognite sono rimaste tali, malgrado tutto ciò che si è scritto intorno ad esse prima, durante e dopo l’avvento del darwinismo.
È inutile sperare che sulla evoluzione delle forme organiche si possa formulare una teoria soddisfacente, se prima non si stabiliscono le leggi della variabilità e dell’eredità. Non dico già che sia necessario conoscere l’essenza di questi due fenomeni; ma le leggi con cui si svolgono. Allora soltanto potrà aversi una teoria della evoluzione paragonabile a quella della gravitazione universale.
Tutto il movimento post-darwiniano si aggira intorno a questi due punti.
Lamarck aveva, com’è noto, attribuito agli agenti esterni una grande importanza come fattori di variabilità; altro fattore era per lui l’uso e il non uso degli organi, provocato anch’esso dalle condizioni in cui vivono gli organismi. Perché gli effetti di queste cause potessero conservarsi e accumularsi attraverso le successive generazioni, era necessario che le modificazioni prodottesi durante la vita individuale si trasmettessero ai discendenti. Questa trasmissibilità ereditaria dei caratteri acquisiti fu ammessa a priori dal Lamarck e poi anche dal Darwin: il quale, sebbene in principio ripudiasse energicamente le idee lamarckiane intorno ai fattori della variabilità, finì per accoglierle in parte pur ritenendo che l’azione preponderante nelle modificazioni delle forme organiche fosse dovuta alla selezione naturale, prodotta dalla lotta per l’esistenza.
Ma la critica post-darwiniana mosse gravi dubbii intorno alla trasmissibilità dei caratteri acquisiti, la quale era più tosto contraddetta che confermata dai fatti. E una nuova tendenza andò affermandosi sotto il nome ormai generalmente accettato di neo-darwinismo. Mentre il Darwin e i darwinisti puri, che ancora oggi seguono l’indirizzo dato dal maestro, accogliendo in parte il lamarckismo, mantengono saldo il principio della trasmissibilità dei caratteri acquisiti; i neo-darwinisti la negano recisamente, e con essa negano ogni effetto degli agenti esterni e dell’uso e del non uso nell’evoluzione, affermando l’onnipotenza della selezione. Le variazioni, secondo i neo-darwinisti, il cui capo riconosciuto è Augusto Weismann, che continua in parte l’indirizzo puramente selezionista del Wallace, sono di due maniere; quelle che interessano il corpo o somatogene e possono manifestarsi durante la vita individuale ma non sono trasmissibili ai discendenti (effetto dell’uso e del non uso delle parti, e degli agenti esterni), e quelle che avvengono nel plasma germinale o blastogene, le quali sole sono ereditarie.
Gl’individui così variati per accidentali variazioni del germe, sono poi sottoposti alla cernita operata dalla lotta per l’esistenza. Quelli che ereditarono variazioni favorevoli prosperano e si riproducono, trasmettendo ai discendenti le variazioni blastogene ch’essi possedevano fin dalla nascita; gli altri presto o tardi sono eliminati.
Per spiegare le variazioni blastogene, o piuttosto per dar ragione della preponderanza di certe variazioni rispetto ad altre − ché della origine prima della variabilità il Weismann, come già il Darwin, non si occupa, − il Weismann ammise anche una selezione intragerminale. Il plasma germinale, pel Weismann, contiene tutt’i caratteri dell’organismo sotto forma di particelle materiali dotate di vita propria: i determinanti; ora queste particelle sono in continua concorrenza fra di loro; alcune, per loro naturale maggior vitalità o per essere situate in condizioni più favorevoli di nutrizione, prosperano e si sviluppano a detrimento di altre meno favorite. I caratteri blastogeni, che escono vincitori da questa lotta, imprimono la loro impronta all’individuo che si sviluppa dal germe e che, sviluppatosi che sia, è poi esposto alla lotta per l’esistenza, che mette capo alla così detta selezione personale.
D’altra parte, si accumularono contro la teoria della selezione le obiezioni della critica, e parve a molti che si fosse corso troppo nel ritenere la selezione come unico o anche soltanto primissimo fattore delle trasmutazioni delle forme. Esaminate una ad una le pretese prove del processo di selezione, non una risultò inattaccabile, e mentre i neo-darwinisti, spogliata la originaria teoria del Darwin di ogni inquinamento lamarckiano, ne conservavano ed esaltavano il solo principio della selezione, decretandolo onnipossente, un’altra scuola, capitanata principalmente dal paleontologo americano Cope, richiamava in onore il puro lamarckismo e, pur concedendo alla selezione un valore relativo, riaffermava la efficacia degli agenti esterni e dell’uso e del non uso quali principalissimi fattori di modificazione organica e, come logica conseguenza, ne riponeva gli effetti essenzialmente nella trasmissibilità dei caratteri acquisiti: così nacque il neo-lamarckismo.
Ma come i neo-darwinisti demoliscono le argomentazioni dei neo-lamarckisti dicendo, e con molte buone ragioni, male o punto provata la trasmissibilità dei caratteri somatici acquisiti: così i neo-lamarckisti negano qualsiasi solido fondamento alle ingegnose speculazioni dei neo-darwinisti, in quanto non vedono dal canto loro nessuna valida prova della efficacia della selezione nel produrre nuove formazioni o vere trasformazioni di organi già esistenti. Essi anzi ritengono si possa a priori escludere quest’azione creatrice della selezione, imperocché, se questa per operare ha bisogno che una variazione utile esista, non si vede come e perché queste variazioni si produrrebbero, e sembra da un lato pochissimo probabile che una variazione fortuita si produca una volta e poi si continui a produrre in senso utile nelle successive generazioni, dall’altro inverosimile che una piccola variazione in una data direzione conferisca tale vantaggio agl’individui che la posseggono da assicurar loro il trionfo nella lotta per l’esistenza. Se la variazione è piccolissima, essa non può aver valore selettivo; se è considerevole, essa s’è dunque già prodotta senza l’intervento della selezione, e questa, inefficace nel primo caso, diventa inutile nel secondo.
Una via di mezzo scelgono i continuatori della pura tradizione darwiniana, i fedeli commentatori del vangelo dell’Origine delle specie nella sua ultima e più lamarckeggiante edizione.
Essi, come il Plate, che n’è il più genuino e attivo rappresentante, sono eclettici e, accettando in parte il lamarckismo, non rifuggono dall’ammettere le trasmissibilità dei caratteri acquisiti, sebbene convengano che le prove che attualmente se ne hanno sono scarsissime e poco concludenti; e si sforzano, d’altro canto, di rafforzare le validità del principio della selezione, col rimettere a nuovo gli antichi argomenti ed escogitarne altri ancora per combattere, ribattere e indebolire, se non altro le obiezioni mosse da ogni parte e alcune delle quali essi pur riconoscono, come già ebbe a riconoscere il Darwin stesso, veramente formidabili.
Queste controversie trasformistiche, come le chiamò il geniale naturalista francese Giard, durano da un pezzo senza che la contesa accenni a calmarsi. Delle centinaia di volumi, di articoli, di discorsi, con cui i campioni dell’una o dell’altra scuola son scesi e scendono ogni giorno in campo, si può dire con Anatole France: “Sans doute les raisons scientifiques de préférer un témoignage à un autre sont parfois très-fortes. Elles ne le sont jamais assez pour l’emporter sur nos passions, nos préjugés, nos intérês, ni pour vaincre cette légéreté d’esprit commune à tous les hommes graves. En sorte que nous présentons constamment les faits d’une manière interessée ou frivolee”!
Non sembri fuor di luogo la citazione del famoso romanziere: molti fra gli scritti darwiniani, neo-darwiniani e lamarckiani hanno del resto più del romanzo che dell’opera scientifica; il che non sarebbe gran male se fossero sempre divertenti; e molte trasformazioni, che vi si trovano raccontate, non sono, a chi ben guardi, meno miracolose di quella operata sui Pinguini dal Santo Maël per volontà del Signore!
La “discendenza con modificazione” del Darwin è fondata essenzialmente, come si sa, sulla variabilità individuale e sull’accumularsi a traverso le successive generazioni, delle variazioni favorevoli. Questo processo si deve supporre lentissimo e per conseguenza, nell’ipotesi darwiniana, l’evoluzione si sarebbe compiuta durante lunghissimi periodi di tempo.
Siccome non si può stabilire, con una sia pure grossolana approssimazione, la durata delle formazioni geologiche, che hanno dato origine alla crosta terrestre, la comparsa della vita poteva rimandarsi a un’epoca antichissima, e i darwinisti non credevano dover limitare in nessun modo la durata presumibile della evoluzione degli esseri. Milioni di secoli potevano essere tranquillamente concessi all’opera creatrice. Ma alcune considerazioni fatte dai fisici, in base a varii calcoli sul tempo necessario al raffreddamento della terra e al disciogliersi dei sali nell’acqua, hanno condotto a ritenere molto probabile che la vita sul nostro pianeta non sia potuta cominciare in epoche così fantasticamente remote, e che la crosta terrestre conti meno milioni di secoli di quelli che le attribuivano i darwinisti. Di necessità dunque, il processo dell’evoluzione non poté essere così lento e così lungo come essi credevano. Sembra perciò inammissibile che ci sia stato il tempo sufficiente alle lentissime modificazioni invocate dal darwinismo. Questo incontra dunque un’altra gravissima difficoltà.
È vero che il Darwin ammise che, oltre le piccole variazioni individuali, avvengano alcune improvvise variazioni che da una generazione all’altra possono profondamente modificare una specie; ma egli considerando, e forse con ragione, che queste variazioni saltuarie che egli chiamò single variations, sono rare, attribuiva loro un valore affatto secondario nel processo dell’evoluzione, e tenne fermo come principalissimo, se non unico, punto di partenza della trasformazione delle specie, le piccole variazioni individuali o variazioni fluttuanti, che s’incontrano sempre nei diversi individui d’una specie o anche nei discendenti d’una coppia.
Il De Vries invece, con la sua teoria della mutazione, viene a sostenere che sono appunto le variazioni saltuarie quelle destinate a fornire il materiale per la formazione delle nuove specie e, in generale, per la evoluzione del mondo organico, mentre le ordinarie variazioni individuali non sono atte a produrre nulla di nuovo.
Ugo De Vries, il dotto botanico olandese, ebbe ad osservare in una località nei pressi di Amsterdam un buon numero di piante di Oenothera lamarckiana, che vi crescevano spontanee, e tra esse ne notò alcune che per varii e spiccati caratteri differivano dalle altre. Trasportati quest’individui aberranti nell’orto botanico di Amsterdam, ei li mise a coltura tenendoli isolati e garantendoli da una eventuale fecondazione con altro polline. Queste piante si riprodussero per seme, rimanendo fedeli ai loro caratteri attraverso numerose generazioni. Avendo poi coltivate in condizioni di perfetto isolamento alcune piante di Oenothera lamarckiana tipica, tolte al luogo natìo, egli constatò che a ogni nuova generazione, fra una maggioranza di piante della specie originaria, ne comparivano sempre alcune spiccatamente diverse, che egli chiamò “mutanti”, dando il nome di mutazione a questo improvviso manifestarsi di nuovi caratteri. Questi mutanti, garentiti sempre da possibili incrociamenti, si mantenevano puri. Così il De Vries, continuando le sue colture per varii anni, ottenne un certo numero di specie ben definite e costanti, originatesi per mutazione dalla specie madre.
Questo interessante risultato condusse il De Vries a elaborare la sua teoria. Egli ammise che in ogni specie possano manifestarsi certi periodi in cui avvengono siffatte mutazioni improvvise, le quali danno origine a nuove specie. Le specie linneane generalmente noverate nella sistematica sono spesso riunioni di varie piccole specie ben definite, le quali si sarebbero originate per mutazione. Su queste forme mutate agisce poi la selezione naturale, nel senso che le mutazioni favorevoli prosperano e si riproducono, sia accanto alla pianta madre, sia soppiantandola completamente, quelle non favorevoli vengono eliminate dalla lotta per l’esistenza.
La teoria della selezione, sotto questa nuova forma, si sottrarrebbe alle due più gravi obiezioni mosse al darwinismo; quella cioè della poca verisimiglianza che le piccole deviazioni possano prestarsi al processo di selezione, e quella del tempo eccessivamente lungo richiesto per le lente trasformazioni.
L’evoluzione per mutazioni procede molto più spiccia e la subitanea comparsa di forme diverse rende molto più verisimile il processo della selezione. Merito grandissimo del De Vries è stato l’aver nettamente distinte le mutazioni o variazioni saltuarie, già note, come dicemmo, al Darwin, ma ritenute di secondaria importanza, e le variazioni individuali o fluttuanti. Queste, per il De Vries, sono variazioni quantitative o statistiche, come soglion dirsi, le quali non sono ereditarie, non offrono presa alla selezione, e si muovono sempre intorno a un valore medio non oltrepassando certi limiti, secondo la legge del Quetelet.
Ora il Darwin non distinse in modo preciso le varie maniere di variabilità, ciò che del resto era scusabilissimo, perché ai suoi tempi quasi nulla si sapeva delle leggi della variabilità individuale, delle oscillazioni intorno a un valore medio, delle curve di frequenza. Gli studii iniziati dagli antropologi, e proseguiti poi nel campo delle specie zoologiche, hanno gettato negli ultimi decenni vivissima luce su questo argomento, fornendo al De Vries un ampio materiale di osservazioni.
La mancanza di serie nozioni sulle leggi della variabilità doveva necessariamente togliere ogni solida base a una teoria che si fondava essenzialmente sulla variabilità. Ma, se non deve farsi colpa al Darwin della sua ignoranza, mi pare d’altra parte irragionevole accusare il De Vries, come fa per es. il Plate, di non aver bene interpretato le idee del Darwin e di aver creduto a torto che le fluttuazioni del Darwin sieno proprio le variazioni individuali o statistiche.
Il Darwin non si preoccupò punto d’indagare la vera natura delle varie forme di variabilità, e fece di ogni erba fascio; sicché è molto difficile, se non impossibile, ricavare dalle sue opere precise definizioni. È però indiscutibile ch’egli, nelle piccole variazioni poste a fondamento della sua teoria, aveva proprio di mira la variabilità individuale. Le variazioni dette meristiche, cioè del numero di parti simili che si ripetono, come per es. il numero delle vertebre, dei denti, dei petali etc. sono, è vero, discontinue, ma rientrano pur sempre nella variabilità oscillante, o fluttuante che dir si voglia, e mi pare che il De Vries abbia perfettamente ragione di opporre queste forme di variabilità a quella saltuaria, che il Darwin anche conobbe e distinse, sebbene non in modo abbastanza preciso.
La teoria della mutazione, accolta da alcuni con entusiasmo e ritenuta tale da poter senz’altro fornirci una soddisfacente soluzione del problema della evoluzione, è stata da altri aspramente attaccata. E in vero bisogna riconoscere che, se il De Vries è stato insuperato maestro nella critica e nell’analisi della variabilità, e con molta sagacia e copia di argomenti ha saputo mettere in evidenza il punto debole del darwinismo, dimostrando falso l’assunto della efficacia delle piccole variazioni individuali come fattori di evoluzione, ha poi a sua volta costruito su debolissime basi.
La sua teoria sembra a tutta prima avere il pregio grandissimo di fondarsi sull’esperimento. Ma è prima di tutto discutibile l’interpretazione dell’esperimento stesso. La Oenothera lamarckiana, pianta originaria del Texas, non è stata più ritrovata allo stato selvaggio nella sua patria. Le Oenothere europee sono piante rinselvatichite da piante coltivate. È dunque ben lecito il dubbio, mosso da molti botanici, intorno alla purezza della specie, e alla possibilità che le pretese mutazioni assunte dal De Vries sieno prodotti di sdoppiamento di una forma ibrida.
È vero che le mutazioni non si lasciano ricondurre ad alcune leggi che regolano la discendenza degl’ibridi, ma è pur vero che se noi oggi, grazie alle geniali antiche osservazioni del Mendel, ripetute ed estese negli ultimi tempi da valorosi ricercatori, quali il De Vries stesso, il Correns ed altri, conosciamo assai bene alcune leggi dell’ibridismo, siamo ben lungi dal conoscerle tutte.
Ma, se pure si vuole accettare senza discussione il risultato dell’esperimento del botanico di Amsterdam, e mandargli buone le sue mutazioni della Oenothera, questo esperimento rimane quasi unico, né c’è finora alcun’altra prova diretta della comparsa di mutazioni in molte specie. Generalizzare da uno o pochi casi è per lo meno avventato.
Né questo è il solo punto debole della nuova teoria. Il numero di mutanti ottenuto dal De Vries è, nel caso più favorevole, una piccolissima percentuale della totalità degl’individui di una generazione: e se in natura i mutanti sono così scarsi, sembra poco probabile ch’essi possano resistere e affermarsi nella lotta per l’esistenza con i numerosissimi compagni non mutati, e sottrarsi all’azione della fecondazione incrociata, quando il De Vries non sarà lì per coprire i loro fiori con sacchetti di carta pergamena. E concedendo anche che questi mutanti godano dell’isolamento riproduttivo nel senso del Gulick; che, cioè, sieno, per loro natura, per effetto della stessa mutazione, incapaci di essere fecondati da polline estraneo; come mai queste rare e poche, e in realtà, non molto profonde e radicali mutazioni, ci possono dar ragione delle frequenti, numerose, complesse e profonde modificazioni che pur sono dovute avvenire nel corso della evoluzione del mondo organico? E qual più verisimile spiegazione ci forniscono le supposte periodiche mutazioni dei tanti e complicati adattamenti organici?
La teoria della mutazione presenta in sostanza tutte le deficienze del vecchio Darwinismo senz’aver su questo sensibili vantaggi; né può sperare di esercitare il fascino di quello. Oramai noi siamo meno disposti a lasciarci ingannare dai facili miraggi.
Accanto a queste, che si potrebbero dire le scuole classiche dell’evoluzionismo moderno, non sono mancati qua e là i tentativi di alcuni audaci combattenti in ordine sparso per la spiegazione del difficile enigma. Questi evoluzionisti minori, ora si sono limitati a escogitare qualche principio sussidiario con cui puntellare parte dell’edifizio di una delle grandi teorie minacciante rovina, ora sono scesi in campo con qualche nuova idea, la quale non ha avuto sufficiente forza espansiva ed è rimasta più o meno ignorata.
Fra i primi meritano speciale menzione coloro che hanno fatto valere l’efficacia dell’isolamento come fattore di evoluzione.
Una difficoltà comune alle principali teorie evoluzionistiche in discussione è la inevitabile azione livellatrice dell’incrociamento. Comunque si ammetta avvenuta una modificazione, sia per effetto della selezione, sia per mutazione, sia per l’azione degli agenti esterni, o per l’uso e il non uso di un organo, se essa si è manifestata in un limitato numero d’individui d’una specie, sarà continuamente contrastata dai possibili incrociamenti con gl’individui che non si sono modificati e che sono i più numerosi, e dalla concorrenza di questi.
A conservare la modificazione ha efficacia grandissima l’isolamento delle forme modificate. Ciò vediamo continuamente avvenire nella selezione delle razze degli animali domestici e delle piante coltivate, per le quali l’isolamento è la condizione prima perché la razza si mantenga pura. Ora in natura si possono verificare in vario modo le condizioni d’isolamento. Primo forse a mettere in evidenza questo fatto, e a farne valere la importanza per la evoluzione delle forme, fu Moritz Wagner, che fin dal 1868 cercò di dimostrare l’importanza delle migrazioni e dell’isolamento geografico, o topografico che dir si voglia, nella formazione delle specie.
Molte osservazioni e considerazioni sulla distribuzione geografica degli animali e delle piante e sulle faune e flore di alcune località hanno poi sempre più chiaramente dimostrata l’importanza dell’isolamento topografico nella conservazione di alcune specie.
Altra forma d’isolamento è quello che, con termine generale, può dirsi biologico, e comprende tutti i varii fattori che contribuiscono a segregare una specie, ostacolando o impedendo la fecondazione incrociata. È soprattutto importante l’isolamento riproduttivo, dovuto al fatto che in una specie in formazione la fecondazione riesce possibile e efficace soltanto fra gl’individui variati in quella data direzione mentre, per condizioni, ora morfologiche, ora fisiologiche, diventa assolutamente impossibile, o per lo meno inefficace, l’accoppiamento con individui non variati.
Il cambiamento d’abitudini e d’istinti d’un gruppo d’animali può anche avere per conseguenza un isolamento più o meno completo.
Il Gulick più di tutti ha studiato, negli ultimi tempi, questo fenomeno complesso dell’isolamento e con accurate osservazioni e argute considerazioni ha contribuito a metterne bene in evidenza i varii lati. Tuttavia nessuna delle varie forme d’isolamento può ritenersi, per sé sola, fattore di variazione.
Ed è appunto per spiegare l’andamento delle variazioni che sono state formulate altre ipotesi. Mentre i darwinisti e neo-darwinisti ammettono variazioni fortuite in ogni direzione, le quali poi verrebbero per così dire incanalate e dirette dalla selezione naturale, altri credono che le variazioni avvengano secondo linee determinate, e che l’evoluzione delle forme proceda lungo vie tracciate che debbono necessariamente condurre a una data méta, o come suol dirsi per ortogenesi. Alcuni fra gli ortogenisti francamente rinunziano a una spiegazione meccanistica e affermano doversi riconoscere negli organismi viventi una insita tendenza a variare secondo date direzioni. Così il Nägeli col suo “principio di perfezionamento”. Le linee della evoluzione sono immanenti, immutabili, e tendono verso una méta ideale prestabilita.
Nello stesso ordine d’idee mi par che si muova, se ben lo intendo, il nostro Rosa con la sua recentissima “Ologenesi”. Egli paragona infatti l’evoluzione filogenetica degli esseri a quella ontogenetica, per cui da un ovo si sviluppa un dato organismo.
Secondo lui, come l’ovo si divide e suddivide in cellule, che poi, nel processo dello sviluppo, vanno differenziandosi in questa o quella parte del corpo, così, da alcune specie di organismi, che prima comparvero sulla faccia della terra, si sono andate man mano originando per sdoppiamenti dicotomici successivi nuove forme secondo determinate direzioni. Le successive faune e flore che hanno popolato il nostro pianeta sono il risultato necessario di questo ripetuto sdoppiamento: esse erano già in potenza nei primitivi organismi originarii.
Il Rosa afferma di non aver trovato nessuna grave obiezione contro questa ipotesi; e si sforza di dimostrare, con esempii desunti dalla distribuzione geografica degli esseri, dalla paleontologia etc., che, mentre le altre teorie evoluzionistiche sono impotenti a darci ragione di molti fatti, nessun fatto conosciuto contrasta la sua.
E infatti è chiaro che simili teorie deterministiche non saranno mai contraddette dai fatti; perché esse ammettono, per ipotesi, che questi non potessero essere diversi da quelli che sono. Sol che il punto di partenza non è diverso da un atto di fede, il quale, se può servire ad acquetare la nostra mente, non può pretendere al carattere d’una spiegazione scientifica e solo acquisterebbe valore, quando si potesse dimostrare che non è possibile altra spiegazione. E questa dimostrazione si farà aspettare un pezzo.
Tanto nel processo di sviluppo d’un organismo da un ovo, quanto in quello della evoluzione del mondo organico, noi ci troviamo in presenza delle due eterne incognite: eredità e variabilità. Dire che nell’un caso e nell’altro la conseguenza era potenzialmente contenuta nella premessa equivale a confessare la nostra completa ignoranza dell’essenza dei processi che si vorrebbero spiegare.
Naturalmente, come tutte le forme di determinismo, anche questo determinismo biologico non ammette contraddizione categorica, perché non si può negarne la possibilità; ma esso rimane, come le altre, una sterile affermazione, la quale, se accettata, deve logicamente precludere la via a ogni ulteriore indagine.
La teoria ortogenetica dell’Eimer, ammette anche essa che le variazioni non avvengano secondo ogni direzione; ma hanno, per così dire, alcune vie tracciate lungo le quali soltanto possono svolgersi. Ma queste vie sono imposte al plasma “da influenze esterne costanti, dal clima, e dalla nutrizione...”.
“A prescindere dal fatto”, dice l’Eimer, “che l’assunto nägeliano d’uno sviluppo precisamente determinato è affatto ipotetico, non dimostrato dai fatti, lo zoologo, che a ogni passo incontra regressi, non può accettare l’esistenza d’un siffatto fattore interno di progresso.
Questo impulso al progresso fondato sull’assunto di speciali ‘leggi formative interne’ contraddice anche l’assunto delle influenze esterne come causa di variazione ... E io credo invece che appunto queste influenze esterne e i processi fisiologici che ne dipendono sieno i fattori determinanti tanto dell’evoluzione filetica quanto di quella individuale”.
I fatti che si possono invocare a favore di un’evoluzione ortogenetica e mal si spiegano con la semplice selezione sono:
- le variazioni parallele o analoghe;
- le formazioni eccessive;
- la costituzione propria dell’organismo, che si oppone a certe variazioni, d’onde l’impos-sibilità di ottenere alcuni prodotti negli allevamenti e nell’orticoltura;
- correlazioni, che limitano l’ampiezza della variazione;
- alcuni fatti paleontologici. Dovunque si incontra un abbondante materiale, che permetta di ricostruire un albero genealogico, si veggono poche direzioni evolutive che, malgrado alcune ramificazioni laterali, decorrono essenzialmente in linea retta;
- le catene di forme di specie recenti, cioè più specie che possono collegarsi con forme di passaggio così da doversi ritenere come appartenenti a una unica direzione evolutiva.
L’Eimer elaborò la sua teoria in opposizione a quella della selezione; ma anche i selezionisti sono non di rado implicitamente o anche esplicitamente ortogenisti. Sol che essi ammettono che l’ortogenesi fornisca materiale per la selezione. La selezione conserva le direzioni di variazioni utili e annienta le dannose. A indicare questa presunta azione combinata dei due processi naturali, il Plate ha proposto la parola ortoselezione.
Secondo il Plate conviene nettamente distinguere l’ortogenesi e l’ortoselezione che ne consegue, nel senso Eimeriano, dall’ortogenesi Nägeliana: e tal distinzione credeva, come abbiam veduto, essenziale lo stesso Eimer nello esporre la propria teoria.
Per definire queste due tendenze il Plate propone anche due nuove parole: ortogenesi autogenetica e ortogenesi ectogenetica.
Ma, a chi ben guardi non sfuggirà che una ortogenesi ectogenetica, quale credette poterla fondare l’Eimer e quale è pronto ad accoglierla il Plate, presuppone necessariamente una ortogenesi autogenetica; perché si fonda in sostanza sulla costituzione dell’organismo stesso. Se gli organismi fossero identici, e un’azione continuata identica delle influenze esterne fosse capace di determinare una data linea di variazione, questa dovrebb’essere identica per tutti gli organismi. Se gli organismi − e nessuno contrasta questo fatto − son diversi, essi sono diversi per virtù propria e dunque hanno già in sé sostanzialmente, per lo meno, uno dei fattori della propria evoluzione; così che, se non m’inganno, qualunque interpretazione ortogenetica non può essere completamente spoglia di determinismo.
Le tendenze conciliative, che vanno qua e là affermandosi ai nostri giorni e di cui il Plate ci offre un caratteristico esempio, sembrano a tutta prima ragionevolissime. In ogni teoria c’è pure qualche cosa di vero: perché non cogliere questi fiori di verità e farne un bel mazzo che potrebbe rappresentare la verità vera e completa? Ma questi fiori, così seducenti sul loro stelo, quando vogliamo coglierli, ci si sfrondano fra le mani.
Le verità che troviamo nelle varie teorie, o sono ovvie, o dubbie, quasi sempre sterili e incapaci per se stesse di sostenere la teoria.
La lotta per l’esistenza è un fatto innegabile, ma se le si toglie la più che dubbia conseguenza della selezione, non ci aiuta per nulla a spiegarci l’evoluzione. L’effetto dell’uso e del non uso degli organi è evidente; ma, se non è accoppiato alla trasmissibilità dei caratteri acquisiti, a nulla giova come fattore di nuove forme.
Le mutazioni esistono, ma non si sa bene che cosa siano, né dove possano condurre. L’isolamento nelle sue varie forme può certo contribuire a mantenere pura e distinta una specie, ma non può creare caratteri. La ortogenesi non ha di sicuramente vero che la constatazione di un fatto.
E quando tentiamo di mettere insieme le varie teorie, ci accorgiamo che, per completare l’una, abbiano bisogno proprio di ciò che è meno vero dell’altra. I selezionisti eclettici, per potersi servire del Lamarckismo, debbono ammetterne l’ipotesi meno fondata: la trasmissibilità cioè dei caratteri acquisiti; i mutazionisti debbono aprir le braccia alla selezione; e così, per rafforzare le proprie debolezze, ogni teoria deve appoggiarsi sui punti più deboli dell’altra; la sorte dei castelli di carta minaccia questi poco accorti connubii. I compromessi fra le varie teorie significano chiaramente che nessuna ci soddisfa.
Con un po’ di selezione, un tantino di Lamarckismo, e magari qualche mutazione; il tutto sostenuto, perché stia ben dritto, da una ortogenesi di buona qualità, ci sforziamo di mantenere in piedi un edificio, che potrà forse avere bell’apparenza, ma resta pur sempre costruito sulla sabbia.
Il movimento evoluzionistico determinato dal Darwinismo è stato scientificamente fecondo, perché ha messo in luce certi aspetti della natura che prima non vedevamo o vedevamo appena indistintamente; ma il meccanismo della evoluzione delle forme organiche ci è tuttora ignoto.
- Dettagli
- Scritto da Giovanni Gentile
- Categoria: Conferenze
- Visite: 968
Nel riprendere la nostra consuetudine delle pubbliche letture e conferenze, che attrassero già l’anno scorso l’attenzione degli spiriti più colti della nostra città su questa istituzione appena nata, e
possiamo anche dire che suscitarono e accrebbero in molti l’interesse per le questioni filosofiche, vogliate consentire, o Signori, che io brevemente chiarisca gl’intenti, a cui si sono ispirati coloro
che hanno creata questa Biblioteca, e sperano farne un istituto perpetuo della cultura palermitana.
Altri ci avevano preceduti altrove. In parecchie delle principali città italiane, prima o dopo di noi, sono sorti circoli e sodalizi, con o senza biblioteca, allo scopo di promuovere gli studi e la cultura
filosofica. Onde, se la nostra società e biblioteca si distingue da tutte le altre istituzioni congeneri, noi crediamo, per la complessità e organicità dei mezzi con cui procura ad adempire i suoi fini,
l’iniziativa nostra a Palermo si rannoda a un largo movimento dello spirito contemporaneo, più vivace forse in Italia che altrove, il quale è buon argomento a sperare un profondo, energico
risveglio delle forze nostre interiori, che sono poi le sole forze di un popolo. Negli studi nostri, con l’occhio a quelle manifestazioni della cultura che toccano direttamente i problemi che c’interessano,
noi tutti che ci occupiamo di filosofia sentiamo di assistere, spettatori e attori, a un notevole risveglio dello spirito filosofico.
Si fondano riviste, si pubblicano libri, si avviano collezioni, alle quali, dieci anni fa, sarebbe sembrata follia sperare un conveniente numero di lettori. E le riviste moltiplicano ogni anno la
tiratura, e dei libri si chiedono sollecite le nuove edizioni, le collezioni pigliano piede e ampliano il loro disegno. I giornalisti, che fino a ieri preferivano civettare con le scienze naturali e beffarsi della
filosofia, ora ostentano la loro competenza e il loro interesse per le questioni filosofiche.
La filosofia esce dalla umbrabile erudizione delle scuole semideserte, dell’ozio muto delle accademie, dall’irto tecnicismo dei contributi scientifici, e si mescola alla vita, alle passioni, alle
discussioni, alle lotte di tutti gli spiriti colti, accomunati dall’aer libero della vita letteraria, morale e politica.
Ma la filosofia è uscita dalle scuole, dalle accademie e dalle memorie degli specialisti quando già s’era trasformata e li dentro non poteva più respirare. Errore sarebbe il credere che sia trasformata
dopo esserne uscita, al contatto della vita. Quella filosofia del filosofio fatuo e pedante, che fa le spese della commedia dalle nuvole di Aristofane al Socrate immaginario del Galiani, la filosofia del
professionale della filosofia, non sarebbe mai venuta in piazza senza farsi canzonare. E nelle sue ultime forme essa aveva acquistata almeno questa malizia, di starsene bene appartata; e, anche
chiamando intorno a sé un pubblico piuttosto esteso, preferiva sempre andarsi a rinchiudere nella
sua aula universitaria. La filosofia che penetra oggi nella vita, sa di potervi entrare tra il rispetto di
quanti si occuperanno di lei.
La filosofia, o Signori, in quest’ultimo decennio ha subito una grande trasformazione, senza la
quale tengo a protestare che non io vi avrei incomodati per parlarvi di cose filosofiche; non io avrei
voluto addossarmi la responsabilità di presiedere un circolo filosofico, aperto a tutti i palermitani
amanti di idee. La filosofia nostra, la filosofia di oggi non è più la povera e nuda filosofia, che, con
gran gusto del pubblico, lasciava agli uomini pratici il mondo, la realtà viva e concreta, per
sequestrarsi nelle nuvole e nell’astratto; non è più di quella gran rete universale, dalle cui larghe
maglie scappavano, per tutte le parti, tutti gli uomini e tutte le cose, in cui si dispiega la vita, che
desta il nostro interesse, per cui combattiamo e moriamo. No. Noi, francamente, non ci crediamo in
obbligo, perché filosofi, di lasciarvi soli al grande banchetto della vita, o di fare soltanto la parte di
spettatori con l’animo del sapiente lucreziano contento di contemplare da lungi il tumulto e le
tempeste del mondo. Di quella filosofia solitaria ed astratta ridiamo anche noi, come di un grosso
sproposito, perché una filosofia appartata dalla vita è pure, per noi, una vita appartata dalla filosofia,
ossia il fallimento della filosofia: la quale, se ha un valore, se è una forza, deve penetrare di sé la
vita umana e governarla, informarla di sé. Una filosofia sequestrata dalla vita comune, è anche
divisa nello spirito del filosofo dell’uomo, che è pure nel filosofo; perché, se il filosofo si rinchiude
nel suo mondo intellettuale, l’uomo resta sempre immerso nella realtà sociale e nel tutto. Onde
quella filosofia riuscirà una verità della mente, come si dice, senza essere una verità del cuore: una
verità, stavo per dire, pei gonzi, non per l’uomo vivo operante nel mondo attraverso il complesso
delle attinenze onde ogni individuo è confitto nell’universo.
La filosofia oggi è diventata cosa seria, cosa di tutta l’anima nostra, la nostra fede, il nostro
mondo, la nostra legge. Noi siamo ora profondamente convinti che essa ci può dire una parola per
tutte le forme, per tutti i gradi della nostra attività: nella vita pratica come nella vita teoretica, nella
scienza, in ogni ordine di scienza, come nella religione; e che la parola che essa può dire, ha valore
decisivo e fondamentale, ricrea in un nuovo mondo mentale quel che prima si possedeva, e segna
quindi una nuova via. Noi vediamo altresì che questa parola non scoppia a un tratto nello sviluppo
dello spirito, quando da una sfera si passi all’altra, che sarebbe poi quella della filosofia; che anzi
questa parola suona sempre, più o meno alta, più o meno significativa, in ogni anima, in ogni stato;
e che pertanto la nostra filosofia è la stessa di tutti, cui solo artificio e la irriflessione han potuto
contrapporla, come prosuntuosa legislatrice della vita, cui pretenda di sovrapporsi.
È però noi abbiamo sentito la nostra filosofia come una causa comune e un comune interesse di
tutti gli uomini. E abbiamo aperte le porte, e siamo usciti in mezzo, al pubblico e abbiamo creato
delle società filosofiche, che non voglion essere segreti cenacoli, ma focolari di cultura e centri di
coordinazione spirituale, coi mezzi onde la filosofia, e voglio dire ogni pensiero umano, si alimenta,
la collaborazione mentale tra i vivi (conferenze e discussioni) e la collaborazione coi morti, che non
sono morti perché sopravvivono nei libri.
Le nostre biblioteche, dove lo spirito individuale si unisce al Dio di tutte le religioni, quel Dio
che mai non invecchierà, l’eterno spirito umano, non hanno dommi fissi né sacerdoti privilegiati;
ma chiese sono, dove gli uomini si fanno o si vogliono fare d’uno spirito solo, nel comune, sincero
amore della verità, e attingere dalla universalità dello spirito, dalla simpatia delle menti, da una
fede, che non è più l’ombrosa e intollerante opinione dell’individuo, ma la serena, la aperta
convinzione di molti, il vigore, la energia vittoriosa, che appiana le montagne e apre la via della
vita.
Raccogliamoci, dunque, se vi piace, e studiamo insieme, mettiamo insieme i nostri pensieri, se
ciascuno aspira a un pensiero, cioè a una personalità, che valga più che sia possibile. E questo
modestamente, certo, silenziosamente, umilmente come conviene a chi è conscio della difficoltà
dell’impresa, che è la più alta, la più ardua fatica dell’universo, e il compito perenne inesauribile del
pensiero.
Noi di questa Biblioteca, che abbiamo osato farci iniziatori qui a Palermo, non pretendiamo di aver
fatto se non prova di buona volontà. Dico noi, e dovrei dire quegli, l’unico, che ci ha spronati, e ci
sprona: un nome, che per non ferisce la modestia dell’amico mio a vostro, io non pronunzierò, ma
che è sulle labbra di tutti; un nome, che da venti anni a questa parte è divenuto un simbolo
dell’amore incondizionato e della fede inconcussa nella filosofia qui, a Palermo, e fuori; poiché,
senza essere portato attorno sui frontespizi dei libri, è conosciuto e onorato per ogni luogo, dove è
in onore la filosofia.
A lui in massima parte si deve se questa Biblioteca oggi raccoglie circa ottomila volumi, tra i quali
abbiamo acquistate e ordinate le collezioni amorosamente radunate da uno dei cultori più esimii che
i nostri studi abbiano avuto a Palermo, il prof. Vincenzo Di Giovanni, dal cui nome s’intitola perciò
una delle nostre sale. A lui l’istituzione di un annuario in cui la nostra società pubblicherà quanto
delle nostre conferenze e delle nostre comunicazioni potrà avere un interesse per gli studiosi, e darà
notizia di tutta la nostra vita sociale. A lui pure, in grandissima parte, se per l’anno che oggi
inauguriamo io posso annunziarvi una ricca serie di conferenze e di comunicazioni, onde i cultori di
tutte le scienze porteranno a noi quella parte più squisita dei loro pensieri, dove essi s’imbattono
nella filosofia.
Pagina 1 di 2


