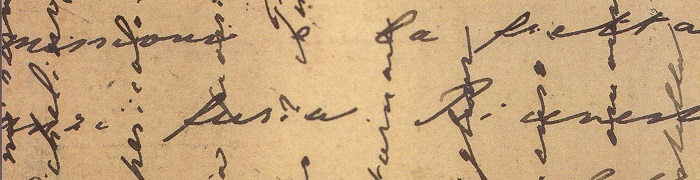Comunicazione letta alla Biblioteca filosofica il 27 nov. 1910, pubblicata su Annuario della Bibl. Fil., vol. I, 1912, pp. 91-112
La storia delle teorie dell’evoluzione è davvero, per chi la sa leggere con animo sereno e, vorrei dire, con spirito di umiltà, una chiara dimostrazione della inanità dei nostri sforzi quando, non contentandoci di conoscere gli aspetti delle cose, ne vogliamo indagare le cause.
Oramai la graduale evoluzione delle forme organiche sul nostro pianeta è generalmente ammessa, fra gli uomini d’una certa cultura, come un fatto quasi altrettanto indiscutibile quanto quello della rotazione della terra intorno al sole, se bene sia ben lungi dall’essere dimostrato, né forse dimostrabile, con pari rigore.
Questa opinione si ritrova, è vero, in qualche filosofo greco e fa capolino qua e là in alcune opere del secolo XVII e XVIII; ma soltanto nel secolo scorso essa cominciò a prender forma di ipotesi scientifica.
Come fondatori del moderno evoluzionismo sono generalmente riconosciuti il Lamarck, il Darwin e il Wallace. Si deve infatti all’opera di questi tre grandi naturalisti, e sopra tutto all’incredibile successo dell’Origine delle specie tutto il grandioso movimento evoluzionistico della biologia moderna.
Il Butler ha ragione di voler rivendicare ad alcuni predecessori e specialmente al Buffon il merito di avere esplicitamente affermato il principio della evoluzione; ma, se la originalità delle idee del Darwin ne viene alquanto scemata, resta pur sempre il fatto innegabile che soltanto dopo la comparsa dell’Origine delle specie, l’evoluzione degli esseri viventi divenne materia di discussione scientifica e di ricerca metodica.
Le vicende del Darwinismo sono note a tutti. Al trionfo, vivacemente contrastato in principio, ma affermatosi poi con una rapidità che forse non ha confronti nella storia delle scienze, successe, verso la fine del secolo in cui il darwinismo era nato, una energica reazione. Lo spirito umano, forse stanco della tirannia, che la nuova teoria gli aveva inflitta per quasi mezzo secolo, si ribellò quando poteva parere completamente soggiogato.
Se fra il 1870 e l’80 era tenuto per retrogrado o corto di mente chi non abbracciasse incondizionatamente la nuova religione − ché tale davvero era diventato il darwinismo per opera degli ardenti suoi apostoli, − sul finire del secolo XIX divenne sospetto di imbecillità congenita ogni darwinista convinto.
L’opera di Carlo Darwin, paragonata già dagli entusiasti a quella del Newton, fu giudicata una colossale mistificazione da un moderno naturalista; un altro definì il darwinismo una malattia inglese da cui era urgente guarire. Articoli e volumi sul tramonto e sulla fine del darwinismo presero il posto degl’innumerevoli scritti che avevano propalato e commentato la “teoria della discendenza” come il libro sacro della biologia.
Oggi chi, senza preparazione, volesse formarsi un giudizio leggendo i tanti libri ed articoli pubblicati pro e contro il darwinismo, rimarrebbe non poco imbarazzato. Mentre in alcuni scritti dei più reputati autori si trova l’affermazione che alla teoria del Darwin può appena concedersi un posto nella storia delle scienze come a un episodio oramai esaurito, si stampano ancora oggi ponderosi Trattati di Darwinismo, nei quali centinaia di pagine sono dedicate a una minuziosa disamina della teoria e questa sembra più viva e vera che mai e tale da trionfare ancora contro tutto e contro tutti.
Come mai, si chiederà l’ingenuo lettore, possono sussistere così opposte opinioni? e dopo tante e così verbose discussioni non può sapersi se la teoria del Darwin sia vera o falsa?
Eppure questo curioso stato di cose era da aspettarsi fin dal primo apparire dell’Origine delle specie. Perché questa teoria della discendenza, apparentemente fondata sui fatti osservati, era in realtà imperniata su due incognite: la variabilità e l’eredità. E queste incognite sono rimaste tali, malgrado tutto ciò che si è scritto intorno ad esse prima, durante e dopo l’avvento del darwinismo.
È inutile sperare che sulla evoluzione delle forme organiche si possa formulare una teoria soddisfacente, se prima non si stabiliscono le leggi della variabilità e dell’eredità. Non dico già che sia necessario conoscere l’essenza di questi due fenomeni; ma le leggi con cui si svolgono. Allora soltanto potrà aversi una teoria della evoluzione paragonabile a quella della gravitazione universale.
Tutto il movimento post-darwiniano si aggira intorno a questi due punti.
Lamarck aveva, com’è noto, attribuito agli agenti esterni una grande importanza come fattori di variabilità; altro fattore era per lui l’uso e il non uso degli organi, provocato anch’esso dalle condizioni in cui vivono gli organismi. Perché gli effetti di queste cause potessero conservarsi e accumularsi attraverso le successive generazioni, era necessario che le modificazioni prodottesi durante la vita individuale si trasmettessero ai discendenti. Questa trasmissibilità ereditaria dei caratteri acquisiti fu ammessa a priori dal Lamarck e poi anche dal Darwin: il quale, sebbene in principio ripudiasse energicamente le idee lamarckiane intorno ai fattori della variabilità, finì per accoglierle in parte pur ritenendo che l’azione preponderante nelle modificazioni delle forme organiche fosse dovuta alla selezione naturale, prodotta dalla lotta per l’esistenza.
Ma la critica post-darwiniana mosse gravi dubbii intorno alla trasmissibilità dei caratteri acquisiti, la quale era più tosto contraddetta che confermata dai fatti. E una nuova tendenza andò affermandosi sotto il nome ormai generalmente accettato di neo-darwinismo. Mentre il Darwin e i darwinisti puri, che ancora oggi seguono l’indirizzo dato dal maestro, accogliendo in parte il lamarckismo, mantengono saldo il principio della trasmissibilità dei caratteri acquisiti; i neo-darwinisti la negano recisamente, e con essa negano ogni effetto degli agenti esterni e dell’uso e del non uso nell’evoluzione, affermando l’onnipotenza della selezione. Le variazioni, secondo i neo-darwinisti, il cui capo riconosciuto è Augusto Weismann, che continua in parte l’indirizzo puramente selezionista del Wallace, sono di due maniere; quelle che interessano il corpo o somatogene e possono manifestarsi durante la vita individuale ma non sono trasmissibili ai discendenti (effetto dell’uso e del non uso delle parti, e degli agenti esterni), e quelle che avvengono nel plasma germinale o blastogene, le quali sole sono ereditarie.
Gl’individui così variati per accidentali variazioni del germe, sono poi sottoposti alla cernita operata dalla lotta per l’esistenza. Quelli che ereditarono variazioni favorevoli prosperano e si riproducono, trasmettendo ai discendenti le variazioni blastogene ch’essi possedevano fin dalla nascita; gli altri presto o tardi sono eliminati.
Per spiegare le variazioni blastogene, o piuttosto per dar ragione della preponderanza di certe variazioni rispetto ad altre − ché della origine prima della variabilità il Weismann, come già il Darwin, non si occupa, − il Weismann ammise anche una selezione intragerminale. Il plasma germinale, pel Weismann, contiene tutt’i caratteri dell’organismo sotto forma di particelle materiali dotate di vita propria: i determinanti; ora queste particelle sono in continua concorrenza fra di loro; alcune, per loro naturale maggior vitalità o per essere situate in condizioni più favorevoli di nutrizione, prosperano e si sviluppano a detrimento di altre meno favorite. I caratteri blastogeni, che escono vincitori da questa lotta, imprimono la loro impronta all’individuo che si sviluppa dal germe e che, sviluppatosi che sia, è poi esposto alla lotta per l’esistenza, che mette capo alla così detta selezione personale.
D’altra parte, si accumularono contro la teoria della selezione le obiezioni della critica, e parve a molti che si fosse corso troppo nel ritenere la selezione come unico o anche soltanto primissimo fattore delle trasmutazioni delle forme. Esaminate una ad una le pretese prove del processo di selezione, non una risultò inattaccabile, e mentre i neo-darwinisti, spogliata la originaria teoria del Darwin di ogni inquinamento lamarckiano, ne conservavano ed esaltavano il solo principio della selezione, decretandolo onnipossente, un’altra scuola, capitanata principalmente dal paleontologo americano Cope, richiamava in onore il puro lamarckismo e, pur concedendo alla selezione un valore relativo, riaffermava la efficacia degli agenti esterni e dell’uso e del non uso quali principalissimi fattori di modificazione organica e, come logica conseguenza, ne riponeva gli effetti essenzialmente nella trasmissibilità dei caratteri acquisiti: così nacque il neo-lamarckismo.
Ma come i neo-darwinisti demoliscono le argomentazioni dei neo-lamarckisti dicendo, e con molte buone ragioni, male o punto provata la trasmissibilità dei caratteri somatici acquisiti: così i neo-lamarckisti negano qualsiasi solido fondamento alle ingegnose speculazioni dei neo-darwinisti, in quanto non vedono dal canto loro nessuna valida prova della efficacia della selezione nel produrre nuove formazioni o vere trasformazioni di organi già esistenti. Essi anzi ritengono si possa a priori escludere quest’azione creatrice della selezione, imperocché, se questa per operare ha bisogno che una variazione utile esista, non si vede come e perché queste variazioni si produrrebbero, e sembra da un lato pochissimo probabile che una variazione fortuita si produca una volta e poi si continui a produrre in senso utile nelle successive generazioni, dall’altro inverosimile che una piccola variazione in una data direzione conferisca tale vantaggio agl’individui che la posseggono da assicurar loro il trionfo nella lotta per l’esistenza. Se la variazione è piccolissima, essa non può aver valore selettivo; se è considerevole, essa s’è dunque già prodotta senza l’intervento della selezione, e questa, inefficace nel primo caso, diventa inutile nel secondo.
Una via di mezzo scelgono i continuatori della pura tradizione darwiniana, i fedeli commentatori del vangelo dell’Origine delle specie nella sua ultima e più lamarckeggiante edizione.
Essi, come il Plate, che n’è il più genuino e attivo rappresentante, sono eclettici e, accettando in parte il lamarckismo, non rifuggono dall’ammettere le trasmissibilità dei caratteri acquisiti, sebbene convengano che le prove che attualmente se ne hanno sono scarsissime e poco concludenti; e si sforzano, d’altro canto, di rafforzare le validità del principio della selezione, col rimettere a nuovo gli antichi argomenti ed escogitarne altri ancora per combattere, ribattere e indebolire, se non altro le obiezioni mosse da ogni parte e alcune delle quali essi pur riconoscono, come già ebbe a riconoscere il Darwin stesso, veramente formidabili.
Queste controversie trasformistiche, come le chiamò il geniale naturalista francese Giard, durano da un pezzo senza che la contesa accenni a calmarsi. Delle centinaia di volumi, di articoli, di discorsi, con cui i campioni dell’una o dell’altra scuola son scesi e scendono ogni giorno in campo, si può dire con Anatole France: “Sans doute les raisons scientifiques de préférer un témoignage à un autre sont parfois très-fortes. Elles ne le sont jamais assez pour l’emporter sur nos passions, nos préjugés, nos intérês, ni pour vaincre cette légéreté d’esprit commune à tous les hommes graves. En sorte que nous présentons constamment les faits d’une manière interessée ou frivolee”!
Non sembri fuor di luogo la citazione del famoso romanziere: molti fra gli scritti darwiniani, neo-darwiniani e lamarckiani hanno del resto più del romanzo che dell’opera scientifica; il che non sarebbe gran male se fossero sempre divertenti; e molte trasformazioni, che vi si trovano raccontate, non sono, a chi ben guardi, meno miracolose di quella operata sui Pinguini dal Santo Maël per volontà del Signore!
La “discendenza con modificazione” del Darwin è fondata essenzialmente, come si sa, sulla variabilità individuale e sull’accumularsi a traverso le successive generazioni, delle variazioni favorevoli. Questo processo si deve supporre lentissimo e per conseguenza, nell’ipotesi darwiniana, l’evoluzione si sarebbe compiuta durante lunghissimi periodi di tempo.
Siccome non si può stabilire, con una sia pure grossolana approssimazione, la durata delle formazioni geologiche, che hanno dato origine alla crosta terrestre, la comparsa della vita poteva rimandarsi a un’epoca antichissima, e i darwinisti non credevano dover limitare in nessun modo la durata presumibile della evoluzione degli esseri. Milioni di secoli potevano essere tranquillamente concessi all’opera creatrice. Ma alcune considerazioni fatte dai fisici, in base a varii calcoli sul tempo necessario al raffreddamento della terra e al disciogliersi dei sali nell’acqua, hanno condotto a ritenere molto probabile che la vita sul nostro pianeta non sia potuta cominciare in epoche così fantasticamente remote, e che la crosta terrestre conti meno milioni di secoli di quelli che le attribuivano i darwinisti. Di necessità dunque, il processo dell’evoluzione non poté essere così lento e così lungo come essi credevano. Sembra perciò inammissibile che ci sia stato il tempo sufficiente alle lentissime modificazioni invocate dal darwinismo. Questo incontra dunque un’altra gravissima difficoltà.
È vero che il Darwin ammise che, oltre le piccole variazioni individuali, avvengano alcune improvvise variazioni che da una generazione all’altra possono profondamente modificare una specie; ma egli considerando, e forse con ragione, che queste variazioni saltuarie che egli chiamò single variations, sono rare, attribuiva loro un valore affatto secondario nel processo dell’evoluzione, e tenne fermo come principalissimo, se non unico, punto di partenza della trasformazione delle specie, le piccole variazioni individuali o variazioni fluttuanti, che s’incontrano sempre nei diversi individui d’una specie o anche nei discendenti d’una coppia.
Il De Vries invece, con la sua teoria della mutazione, viene a sostenere che sono appunto le variazioni saltuarie quelle destinate a fornire il materiale per la formazione delle nuove specie e, in generale, per la evoluzione del mondo organico, mentre le ordinarie variazioni individuali non sono atte a produrre nulla di nuovo.
Ugo De Vries, il dotto botanico olandese, ebbe ad osservare in una località nei pressi di Amsterdam un buon numero di piante di Oenothera lamarckiana, che vi crescevano spontanee, e tra esse ne notò alcune che per varii e spiccati caratteri differivano dalle altre. Trasportati quest’individui aberranti nell’orto botanico di Amsterdam, ei li mise a coltura tenendoli isolati e garantendoli da una eventuale fecondazione con altro polline. Queste piante si riprodussero per seme, rimanendo fedeli ai loro caratteri attraverso numerose generazioni. Avendo poi coltivate in condizioni di perfetto isolamento alcune piante di Oenothera lamarckiana tipica, tolte al luogo natìo, egli constatò che a ogni nuova generazione, fra una maggioranza di piante della specie originaria, ne comparivano sempre alcune spiccatamente diverse, che egli chiamò “mutanti”, dando il nome di mutazione a questo improvviso manifestarsi di nuovi caratteri. Questi mutanti, garentiti sempre da possibili incrociamenti, si mantenevano puri. Così il De Vries, continuando le sue colture per varii anni, ottenne un certo numero di specie ben definite e costanti, originatesi per mutazione dalla specie madre.
Questo interessante risultato condusse il De Vries a elaborare la sua teoria. Egli ammise che in ogni specie possano manifestarsi certi periodi in cui avvengono siffatte mutazioni improvvise, le quali danno origine a nuove specie. Le specie linneane generalmente noverate nella sistematica sono spesso riunioni di varie piccole specie ben definite, le quali si sarebbero originate per mutazione. Su queste forme mutate agisce poi la selezione naturale, nel senso che le mutazioni favorevoli prosperano e si riproducono, sia accanto alla pianta madre, sia soppiantandola completamente, quelle non favorevoli vengono eliminate dalla lotta per l’esistenza.
La teoria della selezione, sotto questa nuova forma, si sottrarrebbe alle due più gravi obiezioni mosse al darwinismo; quella cioè della poca verisimiglianza che le piccole deviazioni possano prestarsi al processo di selezione, e quella del tempo eccessivamente lungo richiesto per le lente trasformazioni.
L’evoluzione per mutazioni procede molto più spiccia e la subitanea comparsa di forme diverse rende molto più verisimile il processo della selezione. Merito grandissimo del De Vries è stato l’aver nettamente distinte le mutazioni o variazioni saltuarie, già note, come dicemmo, al Darwin, ma ritenute di secondaria importanza, e le variazioni individuali o fluttuanti. Queste, per il De Vries, sono variazioni quantitative o statistiche, come soglion dirsi, le quali non sono ereditarie, non offrono presa alla selezione, e si muovono sempre intorno a un valore medio non oltrepassando certi limiti, secondo la legge del Quetelet.
Ora il Darwin non distinse in modo preciso le varie maniere di variabilità, ciò che del resto era scusabilissimo, perché ai suoi tempi quasi nulla si sapeva delle leggi della variabilità individuale, delle oscillazioni intorno a un valore medio, delle curve di frequenza. Gli studii iniziati dagli antropologi, e proseguiti poi nel campo delle specie zoologiche, hanno gettato negli ultimi decenni vivissima luce su questo argomento, fornendo al De Vries un ampio materiale di osservazioni.
La mancanza di serie nozioni sulle leggi della variabilità doveva necessariamente togliere ogni solida base a una teoria che si fondava essenzialmente sulla variabilità. Ma, se non deve farsi colpa al Darwin della sua ignoranza, mi pare d’altra parte irragionevole accusare il De Vries, come fa per es. il Plate, di non aver bene interpretato le idee del Darwin e di aver creduto a torto che le fluttuazioni del Darwin sieno proprio le variazioni individuali o statistiche.
Il Darwin non si preoccupò punto d’indagare la vera natura delle varie forme di variabilità, e fece di ogni erba fascio; sicché è molto difficile, se non impossibile, ricavare dalle sue opere precise definizioni. È però indiscutibile ch’egli, nelle piccole variazioni poste a fondamento della sua teoria, aveva proprio di mira la variabilità individuale. Le variazioni dette meristiche, cioè del numero di parti simili che si ripetono, come per es. il numero delle vertebre, dei denti, dei petali etc. sono, è vero, discontinue, ma rientrano pur sempre nella variabilità oscillante, o fluttuante che dir si voglia, e mi pare che il De Vries abbia perfettamente ragione di opporre queste forme di variabilità a quella saltuaria, che il Darwin anche conobbe e distinse, sebbene non in modo abbastanza preciso.
La teoria della mutazione, accolta da alcuni con entusiasmo e ritenuta tale da poter senz’altro fornirci una soddisfacente soluzione del problema della evoluzione, è stata da altri aspramente attaccata. E in vero bisogna riconoscere che, se il De Vries è stato insuperato maestro nella critica e nell’analisi della variabilità, e con molta sagacia e copia di argomenti ha saputo mettere in evidenza il punto debole del darwinismo, dimostrando falso l’assunto della efficacia delle piccole variazioni individuali come fattori di evoluzione, ha poi a sua volta costruito su debolissime basi.
La sua teoria sembra a tutta prima avere il pregio grandissimo di fondarsi sull’esperimento. Ma è prima di tutto discutibile l’interpretazione dell’esperimento stesso. La Oenothera lamarckiana, pianta originaria del Texas, non è stata più ritrovata allo stato selvaggio nella sua patria. Le Oenothere europee sono piante rinselvatichite da piante coltivate. È dunque ben lecito il dubbio, mosso da molti botanici, intorno alla purezza della specie, e alla possibilità che le pretese mutazioni assunte dal De Vries sieno prodotti di sdoppiamento di una forma ibrida.
È vero che le mutazioni non si lasciano ricondurre ad alcune leggi che regolano la discendenza degl’ibridi, ma è pur vero che se noi oggi, grazie alle geniali antiche osservazioni del Mendel, ripetute ed estese negli ultimi tempi da valorosi ricercatori, quali il De Vries stesso, il Correns ed altri, conosciamo assai bene alcune leggi dell’ibridismo, siamo ben lungi dal conoscerle tutte.
Ma, se pure si vuole accettare senza discussione il risultato dell’esperimento del botanico di Amsterdam, e mandargli buone le sue mutazioni della Oenothera, questo esperimento rimane quasi unico, né c’è finora alcun’altra prova diretta della comparsa di mutazioni in molte specie. Generalizzare da uno o pochi casi è per lo meno avventato.
Né questo è il solo punto debole della nuova teoria. Il numero di mutanti ottenuto dal De Vries è, nel caso più favorevole, una piccolissima percentuale della totalità degl’individui di una generazione: e se in natura i mutanti sono così scarsi, sembra poco probabile ch’essi possano resistere e affermarsi nella lotta per l’esistenza con i numerosissimi compagni non mutati, e sottrarsi all’azione della fecondazione incrociata, quando il De Vries non sarà lì per coprire i loro fiori con sacchetti di carta pergamena. E concedendo anche che questi mutanti godano dell’isolamento riproduttivo nel senso del Gulick; che, cioè, sieno, per loro natura, per effetto della stessa mutazione, incapaci di essere fecondati da polline estraneo; come mai queste rare e poche, e in realtà, non molto profonde e radicali mutazioni, ci possono dar ragione delle frequenti, numerose, complesse e profonde modificazioni che pur sono dovute avvenire nel corso della evoluzione del mondo organico? E qual più verisimile spiegazione ci forniscono le supposte periodiche mutazioni dei tanti e complicati adattamenti organici?
La teoria della mutazione presenta in sostanza tutte le deficienze del vecchio Darwinismo senz’aver su questo sensibili vantaggi; né può sperare di esercitare il fascino di quello. Oramai noi siamo meno disposti a lasciarci ingannare dai facili miraggi.
Accanto a queste, che si potrebbero dire le scuole classiche dell’evoluzionismo moderno, non sono mancati qua e là i tentativi di alcuni audaci combattenti in ordine sparso per la spiegazione del difficile enigma. Questi evoluzionisti minori, ora si sono limitati a escogitare qualche principio sussidiario con cui puntellare parte dell’edifizio di una delle grandi teorie minacciante rovina, ora sono scesi in campo con qualche nuova idea, la quale non ha avuto sufficiente forza espansiva ed è rimasta più o meno ignorata.
Fra i primi meritano speciale menzione coloro che hanno fatto valere l’efficacia dell’isolamento come fattore di evoluzione.
Una difficoltà comune alle principali teorie evoluzionistiche in discussione è la inevitabile azione livellatrice dell’incrociamento. Comunque si ammetta avvenuta una modificazione, sia per effetto della selezione, sia per mutazione, sia per l’azione degli agenti esterni, o per l’uso e il non uso di un organo, se essa si è manifestata in un limitato numero d’individui d’una specie, sarà continuamente contrastata dai possibili incrociamenti con gl’individui che non si sono modificati e che sono i più numerosi, e dalla concorrenza di questi.
A conservare la modificazione ha efficacia grandissima l’isolamento delle forme modificate. Ciò vediamo continuamente avvenire nella selezione delle razze degli animali domestici e delle piante coltivate, per le quali l’isolamento è la condizione prima perché la razza si mantenga pura. Ora in natura si possono verificare in vario modo le condizioni d’isolamento. Primo forse a mettere in evidenza questo fatto, e a farne valere la importanza per la evoluzione delle forme, fu Moritz Wagner, che fin dal 1868 cercò di dimostrare l’importanza delle migrazioni e dell’isolamento geografico, o topografico che dir si voglia, nella formazione delle specie.
Molte osservazioni e considerazioni sulla distribuzione geografica degli animali e delle piante e sulle faune e flore di alcune località hanno poi sempre più chiaramente dimostrata l’importanza dell’isolamento topografico nella conservazione di alcune specie.
Altra forma d’isolamento è quello che, con termine generale, può dirsi biologico, e comprende tutti i varii fattori che contribuiscono a segregare una specie, ostacolando o impedendo la fecondazione incrociata. È soprattutto importante l’isolamento riproduttivo, dovuto al fatto che in una specie in formazione la fecondazione riesce possibile e efficace soltanto fra gl’individui variati in quella data direzione mentre, per condizioni, ora morfologiche, ora fisiologiche, diventa assolutamente impossibile, o per lo meno inefficace, l’accoppiamento con individui non variati.
Il cambiamento d’abitudini e d’istinti d’un gruppo d’animali può anche avere per conseguenza un isolamento più o meno completo.
Il Gulick più di tutti ha studiato, negli ultimi tempi, questo fenomeno complesso dell’isolamento e con accurate osservazioni e argute considerazioni ha contribuito a metterne bene in evidenza i varii lati. Tuttavia nessuna delle varie forme d’isolamento può ritenersi, per sé sola, fattore di variazione.
Ed è appunto per spiegare l’andamento delle variazioni che sono state formulate altre ipotesi. Mentre i darwinisti e neo-darwinisti ammettono variazioni fortuite in ogni direzione, le quali poi verrebbero per così dire incanalate e dirette dalla selezione naturale, altri credono che le variazioni avvengano secondo linee determinate, e che l’evoluzione delle forme proceda lungo vie tracciate che debbono necessariamente condurre a una data méta, o come suol dirsi per ortogenesi. Alcuni fra gli ortogenisti francamente rinunziano a una spiegazione meccanistica e affermano doversi riconoscere negli organismi viventi una insita tendenza a variare secondo date direzioni. Così il Nägeli col suo “principio di perfezionamento”. Le linee della evoluzione sono immanenti, immutabili, e tendono verso una méta ideale prestabilita.
Nello stesso ordine d’idee mi par che si muova, se ben lo intendo, il nostro Rosa con la sua recentissima “Ologenesi”. Egli paragona infatti l’evoluzione filogenetica degli esseri a quella ontogenetica, per cui da un ovo si sviluppa un dato organismo.
Secondo lui, come l’ovo si divide e suddivide in cellule, che poi, nel processo dello sviluppo, vanno differenziandosi in questa o quella parte del corpo, così, da alcune specie di organismi, che prima comparvero sulla faccia della terra, si sono andate man mano originando per sdoppiamenti dicotomici successivi nuove forme secondo determinate direzioni. Le successive faune e flore che hanno popolato il nostro pianeta sono il risultato necessario di questo ripetuto sdoppiamento: esse erano già in potenza nei primitivi organismi originarii.
Il Rosa afferma di non aver trovato nessuna grave obiezione contro questa ipotesi; e si sforza di dimostrare, con esempii desunti dalla distribuzione geografica degli esseri, dalla paleontologia etc., che, mentre le altre teorie evoluzionistiche sono impotenti a darci ragione di molti fatti, nessun fatto conosciuto contrasta la sua.
E infatti è chiaro che simili teorie deterministiche non saranno mai contraddette dai fatti; perché esse ammettono, per ipotesi, che questi non potessero essere diversi da quelli che sono. Sol che il punto di partenza non è diverso da un atto di fede, il quale, se può servire ad acquetare la nostra mente, non può pretendere al carattere d’una spiegazione scientifica e solo acquisterebbe valore, quando si potesse dimostrare che non è possibile altra spiegazione. E questa dimostrazione si farà aspettare un pezzo.
Tanto nel processo di sviluppo d’un organismo da un ovo, quanto in quello della evoluzione del mondo organico, noi ci troviamo in presenza delle due eterne incognite: eredità e variabilità. Dire che nell’un caso e nell’altro la conseguenza era potenzialmente contenuta nella premessa equivale a confessare la nostra completa ignoranza dell’essenza dei processi che si vorrebbero spiegare.
Naturalmente, come tutte le forme di determinismo, anche questo determinismo biologico non ammette contraddizione categorica, perché non si può negarne la possibilità; ma esso rimane, come le altre, una sterile affermazione, la quale, se accettata, deve logicamente precludere la via a ogni ulteriore indagine.
La teoria ortogenetica dell’Eimer, ammette anche essa che le variazioni non avvengano secondo ogni direzione; ma hanno, per così dire, alcune vie tracciate lungo le quali soltanto possono svolgersi. Ma queste vie sono imposte al plasma “da influenze esterne costanti, dal clima, e dalla nutrizione...”.
“A prescindere dal fatto”, dice l’Eimer, “che l’assunto nägeliano d’uno sviluppo precisamente determinato è affatto ipotetico, non dimostrato dai fatti, lo zoologo, che a ogni passo incontra regressi, non può accettare l’esistenza d’un siffatto fattore interno di progresso.
Questo impulso al progresso fondato sull’assunto di speciali ‘leggi formative interne’ contraddice anche l’assunto delle influenze esterne come causa di variazione ... E io credo invece che appunto queste influenze esterne e i processi fisiologici che ne dipendono sieno i fattori determinanti tanto dell’evoluzione filetica quanto di quella individuale”.
I fatti che si possono invocare a favore di un’evoluzione ortogenetica e mal si spiegano con la semplice selezione sono:
- le variazioni parallele o analoghe;
- le formazioni eccessive;
- la costituzione propria dell’organismo, che si oppone a certe variazioni, d’onde l’impos-sibilità di ottenere alcuni prodotti negli allevamenti e nell’orticoltura;
- correlazioni, che limitano l’ampiezza della variazione;
- alcuni fatti paleontologici. Dovunque si incontra un abbondante materiale, che permetta di ricostruire un albero genealogico, si veggono poche direzioni evolutive che, malgrado alcune ramificazioni laterali, decorrono essenzialmente in linea retta;
- le catene di forme di specie recenti, cioè più specie che possono collegarsi con forme di passaggio così da doversi ritenere come appartenenti a una unica direzione evolutiva.
L’Eimer elaborò la sua teoria in opposizione a quella della selezione; ma anche i selezionisti sono non di rado implicitamente o anche esplicitamente ortogenisti. Sol che essi ammettono che l’ortogenesi fornisca materiale per la selezione. La selezione conserva le direzioni di variazioni utili e annienta le dannose. A indicare questa presunta azione combinata dei due processi naturali, il Plate ha proposto la parola ortoselezione.
Secondo il Plate conviene nettamente distinguere l’ortogenesi e l’ortoselezione che ne consegue, nel senso Eimeriano, dall’ortogenesi Nägeliana: e tal distinzione credeva, come abbiam veduto, essenziale lo stesso Eimer nello esporre la propria teoria.
Per definire queste due tendenze il Plate propone anche due nuove parole: ortogenesi autogenetica e ortogenesi ectogenetica.
Ma, a chi ben guardi non sfuggirà che una ortogenesi ectogenetica, quale credette poterla fondare l’Eimer e quale è pronto ad accoglierla il Plate, presuppone necessariamente una ortogenesi autogenetica; perché si fonda in sostanza sulla costituzione dell’organismo stesso. Se gli organismi fossero identici, e un’azione continuata identica delle influenze esterne fosse capace di determinare una data linea di variazione, questa dovrebb’essere identica per tutti gli organismi. Se gli organismi − e nessuno contrasta questo fatto − son diversi, essi sono diversi per virtù propria e dunque hanno già in sé sostanzialmente, per lo meno, uno dei fattori della propria evoluzione; così che, se non m’inganno, qualunque interpretazione ortogenetica non può essere completamente spoglia di determinismo.
Le tendenze conciliative, che vanno qua e là affermandosi ai nostri giorni e di cui il Plate ci offre un caratteristico esempio, sembrano a tutta prima ragionevolissime. In ogni teoria c’è pure qualche cosa di vero: perché non cogliere questi fiori di verità e farne un bel mazzo che potrebbe rappresentare la verità vera e completa? Ma questi fiori, così seducenti sul loro stelo, quando vogliamo coglierli, ci si sfrondano fra le mani.
Le verità che troviamo nelle varie teorie, o sono ovvie, o dubbie, quasi sempre sterili e incapaci per se stesse di sostenere la teoria.
La lotta per l’esistenza è un fatto innegabile, ma se le si toglie la più che dubbia conseguenza della selezione, non ci aiuta per nulla a spiegarci l’evoluzione. L’effetto dell’uso e del non uso degli organi è evidente; ma, se non è accoppiato alla trasmissibilità dei caratteri acquisiti, a nulla giova come fattore di nuove forme.
Le mutazioni esistono, ma non si sa bene che cosa siano, né dove possano condurre. L’isolamento nelle sue varie forme può certo contribuire a mantenere pura e distinta una specie, ma non può creare caratteri. La ortogenesi non ha di sicuramente vero che la constatazione di un fatto.
E quando tentiamo di mettere insieme le varie teorie, ci accorgiamo che, per completare l’una, abbiano bisogno proprio di ciò che è meno vero dell’altra. I selezionisti eclettici, per potersi servire del Lamarckismo, debbono ammetterne l’ipotesi meno fondata: la trasmissibilità cioè dei caratteri acquisiti; i mutazionisti debbono aprir le braccia alla selezione; e così, per rafforzare le proprie debolezze, ogni teoria deve appoggiarsi sui punti più deboli dell’altra; la sorte dei castelli di carta minaccia questi poco accorti connubii. I compromessi fra le varie teorie significano chiaramente che nessuna ci soddisfa.
Con un po’ di selezione, un tantino di Lamarckismo, e magari qualche mutazione; il tutto sostenuto, perché stia ben dritto, da una ortogenesi di buona qualità, ci sforziamo di mantenere in piedi un edificio, che potrà forse avere bell’apparenza, ma resta pur sempre costruito sulla sabbia.
Il movimento evoluzionistico determinato dal Darwinismo è stato scientificamente fecondo, perché ha messo in luce certi aspetti della natura che prima non vedevamo o vedevamo appena indistintamente; ma il meccanismo della evoluzione delle forme organiche ci è tuttora ignoto.